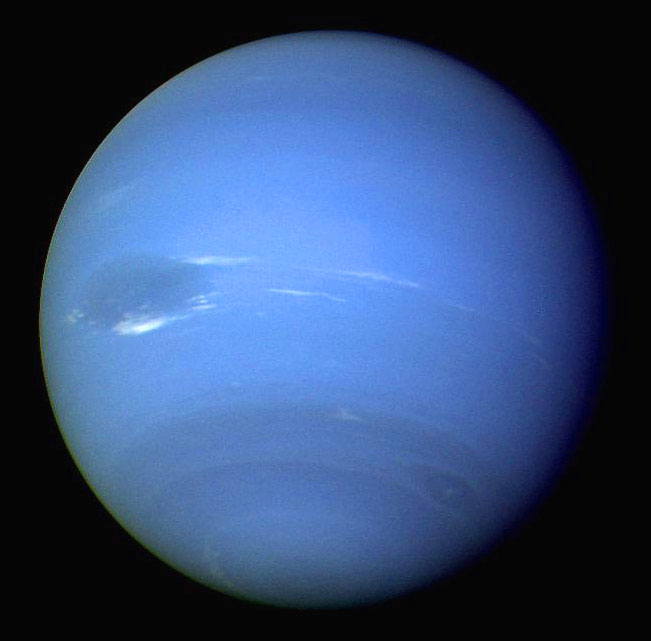di Giuseppe Panella
«Sublime. Termine designante un tipo di esperienza estetica – fatta oggetto di ampia discussione – che è distinta da quella di bello. Nell’estetica contemporanea ogni riferimento al sublime è da tempo caduto in disuso. Già Benedetto Croce negava a questo concetto una genuina valenza estetica, ravvisando in esso un esclusivo riferimento morale; ma neppure in questa sede la filosofia del nostro secolo ha ritenuto opportuno riservare al sublime sviluppi concettuali nuovi o fecondi»
(Enciclopedia Garzanti di Filosofia)
«Rifrazione. Deviazione dei raggi luminosi, rispetto alla direzione originaria, che si verifica sulla superficie di separazione di due mezzi otticamente diversi quando i raggi passano dal primo al secondo mezzo» (Enciclopedia Europea Garzanti)
1. Sul crinale dell’ombra: considerazioni inattuali
L’esercizio della ricerca può insegnarci a evitare equivoci, non a fare scoperte fondamentali. Ci rivela le nostre impossibilità, i nostri limiti severi. Questa mia possibile ricostruzione teorica con variazioni sul tema del sublime può essere attribuita ad un genere: la storia concettuale di figure (o momenti) dell’esperienza estetica e letteraria. Si tratta di un tentativo che ha bisogno di un terreno assai fertile di coltura per avere qualche possibilità di successo dato che l’espressione prima utilizzata può essere considerata quasi un ossimoro: il concetto si forma attraverso astrazioni, la letteratura (la poesia, soprattutto) mediante le sue immagini, i suoi sogni, i suoi miti fondativi.
La ricerca prova a convogliare e a far confluire, in un unico alveo, diversi e maestosi fiumi. Il maestro di questo genere filosofico-letterario è stato, in anni ancora non troppo lontani, Eugenio Garin. In quello saggistico, non temo di fare i nomi di Jorge Luis Borges, Paul Valéry e Miguel de Unamuno. Modelli forse irraggiungibili, naturalmente, ma pur sempre modelli di un tentativo di portare i concetti e la vita fino a un limite estremo di tensione. Le pagine che seguiranno tentano di percorrere una via intermedia che non è ancora la “via regia” della filosofia ma non vuole neppure rivolgersi soltanto al puro sensazionalismo della scrittura, al vuoto ricercare a vuoto l’effetto della parola bella perché vuota di senso e non riempibile se non di effimere alchimie verbali…
«Se mi passo la mano sulla fronte, / se accarezzo le costole dei libri, / se riconosco il Libro delle Notti, / se forzo l’ostinata serratura, / se mi soffermo sulla soglia incerta, / se il dolore incredibile mi annienta, / se ricordo la Macchina del Tempo, / se ricordo l’unicorno sull’arazzo, / se mi rigiro mentre sto dormendo, / se la memoria mi riporta un verso, / ripeto ciò che ho fatto innumerevoli / volte nell’assegnato mio cammino. / Io non posso eseguire un gesto nuovo, / tesso e ritesso la scontata favola, / ripeto un ripetuto endecasillabo, / dico quello che già altri mi dissero, / sento le stesse cose nella stessa / ora del giorno o dell’astratta notte. / In ogni notte si ripete l’incubo, / ogni notte il rigore del labirinto. / Sono la fatica di uno specchio immobile / o la polvere di un museo. / Solo una cosa non gustata attendo, / un regalo, un oro dentro l’ombra, quella vergine morte. (Lo spagnolo / permette la metafora) »
Sono versi di Borges (1) e, se i primi endecasillabi mi appartengono come metafora proiettiva, non credo, invece, nell’infeconda inutilità degli ultimi. Qualcosa, alla fine, resta sempre di ciò che conta. Il proposito che mi ha spinto nell’elaborazione di questo testo ulteriore sul Sublime è stato quello di rendere mobile, dinamico e luccicante ancora un concetto che rischiava di riflettere soltanto la morta gora dell’erudizione e della curiosità scolastica da Wunderkammer o di arrugginire sotto il peso di possibili interpretazioni troppo brillanti esibite per rendere ragione dell’opacità dello sforzo concettuale. Se “ogni notte il rigore del labirinto” riconduce il testo mutilo e segreto di Longino ai suoi epigoni più o meno grandi e innovativi, se, cioè, la vicenda del Sublime si rinnova ogni volta che di esso artisti, critici letterari e cultori di estetica dimostrano di avere necessità e desiderio, doverlo dichiarare è diventato oggi indispensabile, snidandolo dove esso si nasconde o è fin troppo palese perché chi lo cerca sia poi in grado di ritrovarlo (come è accaduto per la grande esperienza della scrittura novecentesca – da James Joyce a Thomas Mann, da Gottfried Benn a Ezra Pound giù giù fino a Wallace Stevens, tutti autori in cui il Sublime conosce un più o meno effimero trionfo).
Per questo motivo, la struttura di questo saggio potrà sembrare in alcuni momenti oscillante, sfocata, invece, in altri punti di riflessione, come avviene quando si proietta la copia di certi vecchi film, ma risulterà pur sempre saldamente incastonata nella dura intelaiatura di un progetto di ricerca: il Sublime appartiene, infatti, alla dimensione profonda e non rimuovibile della conoscenza del rapporto tra soggetto e oggetto ed ogni tentativo di liberarsene, sciogliendolo dialetticamente (come ha provato inutilmente lo Hegel dell’Estetica [2]) è destinato, invece, al fallimento del suo tornare, indenne, a funzionare comunque. Anche per una ragione ben precisa.
Ogni esistenza in via di compimento, così come ogni progetto letterario e ogni tentativo di raggiungere il livello del “grande stile” (come voleva Nietzsche) presuppone un momento di sospensione e di tregua.
«Soltanto i giovani hanno tali momenti. Non parlo dei giovanissimi. No. I giovanissimi, a dire il vero, non hanno momenti. E’ privilegio della prima giovinezza vivere oltre il presente, nella bella ininterrotta speranza che non conosce pause o introspezione. Ci si chiude alle spalle il cancelletto della pura fanciullezza e si entra in un giardino incantato. Persino le sue ombre brillano di speranza, ogni svolta del sentiero ha le sue seduzioni. E non perché si tratti di un paese inesplorato. Si sa bene che tutta l’umanità ha percorso quella strada. E’ il fascino dell’esperienza universale, dalla quale ci si aspetta una sensazione personale o straordinaria – un po’ di noi stessi. Riconoscendo le orme dei predecessori si va avanti, eccitati, divertiti, facendo tutt’uno della cattiva e della buona sorte – del buono e del cattivo tempo, come si dice – la pittoresca sorte comune che serba tante possibilità per chi ha qualità o, forse, fortuna. Già si va avanti. Anche il tempo va avanti, finché si scorge innanzi a noi una linea d’ombra che ci avverte che la regione della prima gioventù, anch’essa, la dobbiamo lasciare indietro. Questo è il periodo della vita in cui possono venire i momenti di cui ho parlato…»(3).
Una stasi, dunque, che non sia puro attendere, un indugio che non sia un mero trattenersi, un meditare che non risulti il puro impedirsi di crescere e di andare successivamente più avanti.
Le secche tranquille dell’esistenza presuppongono sempre che la nave possa arenarsi da un momento all’altro; l’attesa senza tempo di ciò che sta per arrivare e che non si conosce ancora anche se, forse, non lo si vuole neppure portare alla luce, indica soltanto che qualcosa sta per accadere. Sarà il momento giusto, dopo aver tremato per l’angoscia di aver preso la decisione sbagliata; sarà il momento adatto per capire quali leve vadano mosse e quali non possono essere azionate ancora proficuamente. Ogni esistenza comporta una serie di ricerche minuziose (lo stesso avviene di solito anche nella pratica teorica della letteratura e della filosofia): la prima di esse – che è fondamentale ma, in fondo, del tutto inutile – è offerta dalla sicura volontà di sopravvivere; nonostante l’orrore che esso comporta, si tratta pur sempre dell’atto più puro che ogni uomo possa compiere senza vergognarsene. In esso, ciò che è orribile è legato inseparabilmente al Sublime (e, infatti, in questo caso, essere diventa simile a resistere). La seconda – l’antica beffa giocata da Platone all’Occidente – è la caccia alla propria immagine riflessa in un altro specchio, la sanzione definitiva del proprio essere autentico in una diversa esistenza: la richiesta di ricostituire l’unità spezzata dell’androgino, la prova di non risultare sempre uguali a se stessi.
La terza indagine indispensabile è quella rivolta alla definizione del proprio destino (ricerca che unifica le precedenti, senza però fonderle: si può volere l’Altro ma non ritrovare se stessi).
A questo stadio si accede attraverso una scelta che è il segno di una maturità conseguita autenticamente: attraversare il mare d’ombra del non-pensato è ciò che permette, poi, di passare indenni attraverso il deserto di ghiaccio del concetto del proprio esistere. Nel momento di passaggio, allora, avviene sempre, tuttavia, che si indugi, per paura o per eccessiva precipitazione –quella rapidità nell’esecuzione che paralizza il pensiero.
Come nel romanzo di Conrad citato sopra in cui le vele della nave rimangono perfettamente immobili, così nella vita sembra che più nulla possa accadere ancora.
Calma estiva e bonaccia sono simboli di uno stesso malessere – di un indugiare che, paradossalmente, conduce alle stesse scelte di sempre.
Gli errori più vecchi si mescolano ai nuovi e vengono tenuti insieme raccolti dal collante dell’oblio. Mai come quando si attraversa la linea d’ombra si impara quanto l’oblio sia potente e la memoria ottusa. Solo allora, la sostanza del proprio destino (intellettualmente avviluppato com’è a quello generale della specie) si sovrappone allo sforzo di dimenticarsene e lo sconfigge.
Il Sublime è la linea d’ombra della teoria estetica – come quella che attende ciascun marinaio all’Equatore, essa attende pazientemente che le teorie del Bello incappino in qualche punto debole, in una falla, in una dimentica beanza di sé. Solo allora scatta la scelta del “nobile sentire”, del sentimento del dolore che risana, del terrore che appaga e dà piacere, dell’immaginazione che ricrea, senza averlo mai ri-conosciuto, un mondo completamente diverso che si riflette nello spirito creativo e lo rincorre.
2. Il Sublime, l’Orrore, l’ Incommensurabile: le categorie della prossimità tragica del mondo
Il Sublime artistico, nel modo in cui sembra fin dal principio caratterizzare la Modernità, deriva direttamente dal processo di secolarizzazione del divino – alludendo ad esso e alle sue metamorfosi nella Natura, l’esperienza dolorosa a assolutamente necessaria della rivoluzione copernicana e della perdita di centro da parte dell’uomo viene decantata attraverso le forme più disparate (e più terribili) di manifestazione di questa crisi epocale. Secolarizzazione e prospettiva artistica continueranno (come si vedrà in seguito) ad intersecarsi e non solo attraverso l’assunzione salvifica del Sublime (4).
Dopo la sua radicale ridiscussione nelle pagine delle lezioni hegeliane sull’estetica, il pathos della bellezza transiterà nella sua antitesi apparente e rifulgerà nell’apoteosi del grottesco. La figura di Cristo morto (già recitata come epicedio per l’umanità da Jean Paul (5) risorgerà nella passione, sempre rinnovata, sempre rassegnata, della facies ridicola e dolcissima (6) del clown, del saltimbanco, di Pierrot e di Gilles fino a stravolgersi nel dramma inutile e necessario del professor Un-rath (7).
Sarà questa, probabilmente, l’ultima metamorfosi di Socrate: da Sileno a clown, da clown a saltimbanco, da saltimbanco a docile giocattolo nelle mani di una femme fatale (come accade al protagonista di L’Angelo azzurro di Heinrich Mann).
Questo tragitto sarà percorso nel prosieguo dell’indagine qui appena iniziata.
Il punto di partenza rimane il Sublime: nella sua storia e nella sua definizione concettuale è consacrata la parabola del Trascendente da acquisizione certa a dolente nostalgia, da sicuro punto di approdo a lacerante necessità (8). Dal Terrore come catastrofe politica e sofferenza senza giustificazione per coloro che ne sono assoggettati al culto per le rovine, vera e propria epifania del passato, il Moderno assimila il legato classico della sublimità e lo trasforma in qualcosa che è radicalmente diverso dal Bello magniloquente e amplificato che l’Anonimo (per tradizione etichettato come lo Pseudo-Longino) aveva descritto e codificato nelle pagine per noi rimaste mutile del suo ambizioso trattato retorico. Eventi storici, allora, e/o trasformazioni materiali in profondità costellano il passaggio dalla concezione aristotelica del Bello come armonia e moralità a quella, protoromatica (et ultra) del Sublime come orrore e terrore, considerazione disumana dell’umano ed umana tensione verso una salvezza che non può arrivare se non dal “salto mortale” verso il Trascendente (come avviene nel caso di Hölderlin e di von Kleist, ma non soltanto per essi). René Girard lo ha dimostrato esaurientemente analizzando la disperazione romantica che nasce dal rinnegare la trascendenza pur aspirandovi:
«Dietro tutte le dottrine occidentali che si susseguono da due o tre secoli vi è sempre il medesimo principio: Dio è morto, tocca all’uomo prendere il suo posto. La tentazione dell’orgoglio è eterna ma diventa irresistibile nell’era moderna poiché è orchestrata e amplificata in maniera inaudita. La “buona novella” moderna è intesa da tutti. Quanto più profondamente si scolpisce nel nostro cuore, tanto più violento è il contrasto tra questa meravigliosa promessa e la brutale smentita che le infligge l’esperienza. A mano a mano che si gonfiano le voci dell’orgoglio, la coscienza di esistere si fa più amara e solitaria. Eppure essa è comune a tutti gli uomini. Perché questa illusione di solitudine che acuisce la pena? Perché gli uomini non possono alleviare le loro sofferenze condividendole con altri? Perché la verità di tutti è sepolta in fondo alla coscienza di ognuno? Tutti gli uomini scoprono nella solitudine della loro coscienza che la promessa è fallace, ma nessuno è capace di universalizzare questa esperienza. La promessa rimane vera per gli altri. Ciascuno si crede l’unico escluso dal retaggio divino e si sforza di nascondere la maledizione. Il peccato originale non è più la verità di tutti gli uomini come nell’universo religioso, ma il segreto di ciascun individuo, l’unico possesso della soggettività che ad alta voce proclama la sua onnipotenza e la sua padronanza radiosa. […]. Le vittime del vangelo moderno diventano così i suoi migliori alleati. Quanto più si è schiavi tanto più ci si accalora a difendere la schiavitù. L’orgoglio può sopravvivere solo grazie alla menzogna. Ed è la menzogna che mantiene in vita il desiderio triangolare. L’eroe si rivolge appassionatamente a questo altro che sembra fruire, lui sì, del retaggio divino. La fede del discepolo è tanto grande che egli si crede sempre sul punto di carpire il segreto meraviglioso al mediatore. Da quel momento in poi ne gode in anticipo. Si distoglie dal presente e vive nell’avvenire radioso. Nulla lo separa dalla divinità, nulla, tranne il mediatore stesso il cui desiderio rivale è di ostacolo al suo desiderio» (9).
Il ragionamento di Girard è riferito all’intero “universo di discorso” del Moderno (in particolare, alla riflessione metafisica di Dostoevskij), ma trova autorevole e drammatica conferma nella descrizione che von Kleist compie dell’orrore che la condizione umana gli sembra diventata dopo l’evento epocale della rivoluzione del 1789. Allo stesso modo, ma sondandolo poeticamente, ammonisce, invece, sulla necessità del riscontro dell’umano nel campo dell’evidenza del divino proprio Hölderlin nei versi iniziali del suo inno Patmos:
«Vicino / E difficile ad afferrare è il Dio. / Ma dove è il pericolo, cresce / Anche ciò che ti salva. / Nelle tenebre vivono / Le aquile e senza paura / Va la prole delle Alpi sopra l’abisso / Su lievemente costruiti ponti. / Ora, poi che ammassate in cerchio / Stanno le vette del tempo / E i più amati abitano vicino, languendo / Sui monti più separati, / Oh, dacci acqua innocente, / Dacci ali a varcare di là / Con fedelissimo animo e ritornare. // Così parlavo quando / Più veloce ch’io non credessi e lontano / Dove mai sognato avevo / Di giungere, un Genio mi rapì / Dalla mia casa. Balenavano appena / Nel dubbio lume ove andavo / L’ombrosa foresta / E le acque desiderose / Della mia terra; non più conoscevo i paesi. / Quand’ecco, in fresco bagliore, / Misteriosissima / Nel fumo d’oro / Sbocciò crescendo rapida / Coi passi del sole / Con gl’incensi di mille vette / l’Asia ai miei occhi…» (10).
Nella pesantezza della vita e nella levità della poesia risiedono i due poli della metamorfosi del Sublime in epoca romantica (11). Di conseguenza, la Befriedigung è ridotta a sostanza della contraddizione tragica dalla crisi che risulta dalle trasformazioni sociali che esplodono con la double Revolution (la Rivoluzione Francese che è il trionfo del Politico e la Rivoluzione Industriale, sanzione, invece, dell’Economico) e l’ “appagamento” si rivela, di conseguenza, soltanto una sosta di fronte alle macerie del passato, ascolto appassionato della sua voce (come avviene in Hölderlin (12) e von Kleist), senza che si realizzi di nuovo la possibilità di ricondurre l’armonia nel sistema della storia e della poesia. La sospensione della morte è soltanto l‘attesa di qualcosa di forse ancora più spaventoso – la perdita di senso della vita che si manifesta attraverso la consapevolezza dell’esistenza dei limiti della ragione (come accade nel Kant della prima Critica) e dell’importanza del caso (come, invece, in von Kleist).
La rappresentazione di questo processo come è esemplificato nella stagione classica del Gothic Novel è stato brillantemente sintetizzato da Marshall Brown:
«Supponiamo ora di considerare i romanzi gotici come esperimenti mentali che provano i limiti non solo della sopportazione umana, ma più specificamente della ragione umana. E’ dopo tutto tipico che i primi romanzi gotici dedichino molto più spazio ai pensieri e alle sensazioni delle vittime, e (spesso) del demone persecutore, che non ai meccanismi della punizione e del tormento. Che resterebbe di un uomo, si chiedono questi romanzi, se ogni associazione umana, ogni comune percezione, ogni prevista regolarità di causa ed effetto fossero strappate via? Essi, in altre parole, si chiedono che cosa sia l’uomo in sé, privato dei supporti esterni che condizionano le nostre esperienze di tutti i giorni. A quali risorse, ammesso che ne abbia, può attingere la mente in isolamento? Qual è la natura della coscienza pura ?» (13).
La dislocazione del Sublime permette di affrontare la perdita di senso che l’improvvisa fine della relazione tra soggetto e oggetto, tra causa ed effetto, tra percezione e percipiente potrebbe comportare; serve, in sostanza, a stabilire la natura effettiva della conoscenza quando venga deprivata dal supporto dell’esperienza. La sua funzione è quella di andare oltre: comprendere completamente il “mondo misterioso al di là dei limiti della ragione” (14). O riuscire ad accettare il dominio del caso, padroneggiandone gli effetti, impedendo che sia capace di sovrastare gli sforzi di comprensione razionale compiuti dalla mente umana.
La Gothic Sublimity annulla il mito della completa decrittabilità del mondo reale e crea zone d’ombra al suo interno, alternandole a sprazzi di luce.
Le contraddizioni, intessute nel suo contesto sociale, emergono intatte a livello formale: la ragion pura non spiega l’insorgenza del Negativo e non supera quei limiti che essa stessa si è data se non nella consapevole accettazione della verità antinomica della conoscenza. Il soggetto che viene ad essere così costituito dalla sua stessa incapacità ad avere centro, a ricevere unità d’intenti e consapevolezza di sé dal baricentro dell’Io, non è più in grado di ritrovarsi come tale e mostra il proprio disagio (la propria Un-ruhe) attraverso forme artistiche che non sono più riconducibili al reame di Armonia.
Ancora Marshall Brown:
«Imprigionata nell’oscurità e tagliata fuori dall’esperienza concreta, la vittima gotica rigenera dall’interno il proprio spazio e tempo, le pure forme kantiane dell’intuizione sensibile. Inseguita dai Doppelgänger e ossessionata dai demoni, ella mette alla prova le categorie di quantità e qualità. Messa di fronte a poteri soprannaturali, la vittima esperimenta la nascita della casualità. Tagliata fuori dalle proprie radici, ella rimane categoricamente legata all’universo per mezzo dei poteri trascendentali di ciò che Kant chiama la comunità. E soprattutto il mondo gotico rimane inspiegabile, così come il mondo di Kant, poiché è pervaso di contraddizioni. Il fato e il caso, il finito e l’in-finito, le persistenze di entità irreali e l’annullamento di quelle reali: il gotico è prevalentemente il mondo dell’antinomia» (15).
Nella categoria (se di categoria in questo caso si può parlare – come io penso sia possibile a ragion veduta [16]) di incommensurabile, l’antinomia si scioglie nella riflessione sul dominio dell’immaginazione sulle cose. Costruendo la definizione di un oggetto che non dovrebbe avere definizione, l’immaginazione supera l’ostacolo epistemologico rappresentato dalla contraddizione tra finito ed infinito e articola quest’ultimo intorno alle sue condizioni di possibilità: il possibile diventa reale, il sogno acquista la dimensione e lo statuto dell’esperienza, l’inesprimibile viene descritto. Il Sublime nasce, allora, proprio dall’espressione del disagio e della forza dell’Io che emergono da questo stato di cose; la ricerca della conciliazione parte dalla conferma della sua impossibilità.
L’incommensurabile può essere misurato solo dai caratteri che contraddistinguono gli oggetti che ad esso fanno riferimento; la precisione dell’espressione nasce dalla vaghezza dei suoi termini.
Non tanto l’impalpabilità e la scarsa precisione dell’ineffabile sembra costituire la natura segreta del Sublime, quanto la sua capacità di riordinare ciò che la ragione lascia scompigliato, di organizzare ciò che i sensi hanno soltanto appreso confusamente, di regolare ciò che il gioco dell’immaginazione potrebbe liberare improduttivamente.
Il Sublime permette il dominio del e sul caso, il che è l’orrore per la ragione.
E’ quello che avviene in von Kleist dove è l’immaginazione produttiva a filare le trame della razionalità, non l’intelletto o l’esperienza precedente. La tragedia Penthesilea e Das Käthchen von Heilbronn, come lo stesso von Kleist riconosceva in una lettera del 1808, “vanno insieme come il + e il – dell’algebra “; allo stesso modo, Das Erdbeben in Chile e Der Zweikampf hanno la stessa funzione nell’ambito delle sue prove narrative. In essi, quella forma di controllo sulla casualità cui si accennava precedentemente ne rinnova, tuttavia, l’effetto perturbante e ciò che viene spiegato, alla fine, risulta tuttavia inspiegabile (17).
Pentesilea, regina delle Amazzoni, uccide ciò che ama, sbrana ciò che teneramente avrebbe accarezzato, polverizza il suo bisogno d’amore in preda alla furia incomposta del distruggere. Il trionfo del negativo avviene in presenza di un positivo: le due qualità non si elidono, ma coesistono. Non scarica psicopatologica, ma descrizione metafisica, il dramma di Pentesilea è nell’irresolubilità dell’antinomia tragica, nella irriducibilità dell’amore e dell’odio, nell’incommensurabilità del sentimento alla ragione e della passione all’ethos.
“Tutta la sozzura e insieme tutto lo splendore della sua anima”: sono parole di von Kleist; tutta la carica disarmonica del pathos viene utilizzata per dimostrare l’inconsistenza della prescrizione dell’armonia. In questa mancanza di compostezza, nella sua impudica esibizione e nella disperazione che l’avvolge, è la forza del Sublime kleistiano.
Caterina di Heilbronn nasconde nella sua tenerezza la dedizione al sogno che l’ha destinata all’uomo della sua vita. Nella fedeltà a ciò che è intessuto di menzogna, la passionalità dei sentimenti si fa largo ridicolizzando la freddezza calcolatrice dell’intelletto. In un caso come nell’altro, l’impossibilità di sfuggire al destino è compensata dalla sicurezza con cui l’appello all’imponderabile è accettato come sola verità (identico sarà il caso del protagonista del Prinz von Homburg, vittima inconsapevole della collisione dei doveri, dove, tuttavia, lo scarto non è tra etica e realtà, tra morale ed effettualità, ma tra sogno e razionalità, impulso e riflessione).
In von Kleist crolla la fiducia nella consequienzialità di causa ed effetto: non c’è più virtù raziocinativa che possa resistere alla furia del terrore dispiegato. Nessun imperativo, nessun sentimento di naturale pietà, nessuna considerazione umanitaria reggono il filo sottile che collega bestialità e socievolezza (18): la sorte di Jeronimo e Josepha, massacrati dalla folla che li considera colpevoli del terremoto che ha distrutto Santiago del Cile (19) (nella novella omonima) fa da pendant alla vendetta che Pentesilea consuma su Achille. Il “bacio che è un morso ed il morso che è un bacio” (insanabile contraddizione contenuta nell’eros) è l’immagine che consegna poeticamente l’intera contraddizione del soggetto alla dilacerazione esterna. Gli abitanti di Santiago che trovano in un caso estemporaneo la causa di ciò che non riescono a spiegare si accontentano di un simulacro di verità; la violenza degli elementi e quella delle passioni si integrano nella catastrofe tragica e impediscono che si giunga al predominio della lampante chiarezza della razionalità. Il crollo è generale e, come Santiago è spazzata via dalla natura, così i due amanti sono vittime della ragione impazzita che li vuole colpevoli di ciò che non possono aver commesso. La paura e il fanatismo (due facce della stessa medaglia nella secolarizzazione in atto) rendono incommensurabili le cause con i loro effetti. Allo stesso modo, i protagonisti del duello che dà il titolo alla novella omonima sono giocati da un destino più grande di loro e vivono una vicenda in cui sono importanti più o meno quanto le marionette nelle mani del loro burattinaio (20).
Eppure, il gioco di maschere che porta tutti i personaggi della storia a credere l’opposto di ciò che è veramente accaduto nasconde, nonostante lo scioglimento felice della vicenda, una morale più profonda: l’apparenza che condiziona le decisioni prese da ciascuno è più forte dei sentimenti e solo l’intervento esterno di Dio (come accade in Der Zweikampf), non la forza salvifica di essi, può permettere l’avvento reale della giustizia. Il predominio della maschera sul volto, dell’inganno sulla sincerità, della superficie sulla profondità è segno della sua reale superiorità: la forza esibita, non il diritto o la giustizia danno la vittoria. Il doppiofondo costituito dalla realtà è poca cosa rispetto alla violenza degli aspetti apparenti dei rapporti umani: come Friedrich von Trota vacilla sotto il peso dell’effettualità e da esso si risolleverà solo grazie a un miracolo fisiologicamente inaspettato (una ferita che portata a suppurazione l’uccide il suo avversario in duello dopo che questi lo aveva sconfitto sul campo), così Michael Kohlhaas è vittima del suo stesso senso del dovere (21); come la marchesa von O*** (22) è sconfitta dalla pura inspiegabilità dello stato delle cose che lo riguardano, così Gustav si salva quando è ormai convinto di essere perduto, mentre sarebbe sicuramente perito nel momento in cui, tranquillo per la propria salvezza, si fosse abbandonato fiduciosamente nelle mani di chi riteneva la propria salvezza dalla malvagità del nemico (è la vicenda del racconto Il fidanzamento a Santo Domingo, esemplificata dall’aneddoto raccontato nella prima parte del racconto [23]). Vittima e carnefice si equivalgono in un gioco di illusioni che approdano all’identico risultato: il cuore umano è insondabile, la sua crudeltà può raggiungere limiti impensabili, eppure le forze contrastanti della passione possono rimettere sempre in gioco il risultato, rovesciarlo, indicare una soluzione alternativa. In sostanza, il fondo del Sublime kleistiano è intrinsecamente tragico: la dialettica resta aperta, in nome di una follia sempre latente che sembra essere il mistero rivelato del comportamento degli uomini. La Provvidenza è insensata: il cerchio della secolarizzazione si stringe fino a negare il significato dell’intervento divino. Sostanza della Storia è la morte e il dolore che la natura provoca non può essere redento, neppure dalla giustificazione etica della sua necessità (è proprio questo il caso di Michael Kohlhaas [24]). Il trionfo dell’”anima bella” è lontano anni luce dalla sanguinosa epifania kleistiana dell’orrore di vivere.
3. Metaformosi della Sublimità: il Grottesco
Come si è visto, la secolarizzazione e le sue conseguenze sono, dunque, al centro del conflitto: sia in prima età moderna (nella riscoperta del testo di Longino e delle sue implicazioni etiche) sia in epoca romantica (nello scontro tra nostalgia, la Sehnsucht, e la realtà) sia nel momento in cui le illusioni sulla natura soteriologica della poesia impallidiscono definitivamente (nell’epos del disincanto), il passaggio è scandito dalle trasformazioni del concetto.
Se il primo transito (dal Sublime “naturale” a quello “artificiale” della costruzione antropologica del soggetto) è mediato sia retoricamente che filosoficamente dall’emergenza di proprie regole e di relazioni molto ben temperate, il mutamento che interverrà in età romantica è segnato dall’insorgenza del mostruoso e del grottesco. Il Tragico coesisterà con il deforme e con l’orribile: ciò che sembrava in aperta contraddizione con la tradizione aristotelica (25) diviene conciliazione nel segno del crollo della fiducia nella necessità dell’armonia (26).
Cristo, da emblema della tragicità, diventa allegoria nel saltimbanco e nel pagliaccio e non ci sarà bisogno di arrivare fin sulla soglia della città di Zarathustra per verificarlo. Il sogno del neo-classicismo si infrange di fronte all’orrore di ciò che non è più divino, ma ne conserva ancora le stigmate. Figure araldiche di questa metamorfosi sono il clown e l’ibrido, il calco mostruoso del divino. Sarà facile seguirne il percorso sulla scia della grande stagione romantica di metà Ottocento; d’altronde, spinto da tutt’altre motivazioni, anche Jean Starobinski si era già addentrato in questa foresta vergine di simboli (e, tuttavia, resta sorprendente come mai il grande critico letterario non si sia accorto di essere in presenza di una delle più sorprendenti variazioni sul tema del Sublime):
«Depuis le romantisme (mais non certes sans quelque prodrome), le bouffon, le saltimbanque et le clown ont été les images hyperboliques et volontairement déformantes que les artistes se sont plu à donner d’eux-mêmes et de la condition de l‘art. Il s‘agit là d’un autoportrait travesti, dont la portée ne se limite pas à la caricature sarcastique ou douloureuse. Musset se dessinant sous les traits de Fantasio; Flaubert déclarant: Le fond de ma nature est, quoi qu’ on dise, le saltimbanque (lettre du 8 août 1846), Jarry, au moment de mourir, s’identifiant à sa créature parodique: Le père Ubu va essayer de dormir; Joyce déclarant : Je ne suis qu’ un clown irlandais, a great joker at the universe ; Rouault multipliant son autoportrait sous les fards de Pierrot ou des clowns tragiques ; Picasso au milieu de son inépuisable réserve de costumes et des masques ; Henry Miller méditant sur le clown qu’il est, qu’il a toujours été : une attitude si constamment répétée, si obstinément réinventée à travers trois ou quatre générations requiert notre attention. Le jeu ironique a la valeur d’une interprétation de soi par soi : c’est une épiphanie dérisoire de l’art et de l’artiste. La critique de l’honorabilité bourgeoise s’y double d’une autocritique dirigée contre la vocation esthétique elle-même. Nous devons y reconnaître l’une des composantes caractéristiques de la ”modernité”, depuis un peu plus d’une centaine d’années» (27).
Si è in presenza di pagine rivelatrici riguardo alla questione: la passione segreta per il clown, il saltimbanco, il Pierrot è un’aspirazione dell’artista (completamente destituito di ogni missione edificante e parenetica) per ritrovare, rovesciando il segno della sua condizione nella società, il cielo del Sublime: non potendo essere eroe, si fa buffone; non potendo più essere al servizio di Dio o di un principe guerriero e potente, diventa epigono dei giullari del passato. Dio è stato scavalcato dal Progresso, è stato scacciato dal mondo – il tragico Pierrot che canta in versi questa vicenda ormai trascorsa e divenuta senso comune aspira al contatto con qualcosa che lo sostituisca. E’ la vertigine dell’arte che si ritrova nella tensione del trapezio o del filo sospeso sull’abisso; nel travestimento del grottesco, si insinua il sottile terrore della morte metafisica (28).
Solo nel comico (e nel comico più facile, che strappa le risate sgangherate e gli oh! di meraviglia del pubblico di periferia che rimane con il fiato sospeso a seguire il volteggiare dell’acrobata o a divertirsi per le disgrazie fittizie del clown) si trova una traccia che può ricondurre alla pietà; solo nella trasgressione del quotidiano è inscritto il bisogno di un’altra vita, di una purezza che la Metropoli ha definitivamente insozzato con il macadam delle sue arterie a scorrimento veloce.
La maschera che il poeta o l’artista vorrebbero indossare per sempre non è, però, quella di Arlecchino o di Pulcinella (espressione da sempre del “mondo alla rovescia”, dei saturnalia, del riscatto dionisiaco in un unico giorno vissuto da padrone e non più da servo), bensì quella del Pierrot lunare che piange d’amore non corrisposto (29), del Gilles ingenuo e tradito dalla vita e dalle donne, dell’uomo sul filo impavido ed intoccabile, dell’Augusto che muore con “il sorriso ai piedi della scala” (come nell’omonimo, splendido racconto di Henry Miller).
Il circo, i baracconi da fiera, le feste di paese, oltre ad essere i topoi della grande pittura tra Settecento e Novecento (da Watteau a Picasso, da Degas a Rouault, da Toulouse-Lautrec a Utrillo) diventano il luogo della poesia.
Allo stesso modo, la presenza del Sublime invade l’universo mondanizzato della tecnica e si palesa nella kénosis che denuncia definitivamente la non-sacralità dell’arte; si tratta, come ha acutamene richiamato Sergio Givone, dello
«stesso assunto che un autore come Harvey Cox ha legittimamente adottato nell’interpretare la realtà metropolitana e post-moderna come “cenotica”: ossia come definitivamente profana ma d’una profanità che non dice se non lo scendere e lo sprofondare irreversibile del divino nelle periferie, negli spaccati urbani, nei margini d’ilare disperazione che ci restituisce come folle di Dio il graffitista o il break-dancer» (30).
Nella “festa dei folli” di Cox (come nella “festa dei folli” della tradizione carnascialesca, da Rabelais a Victor Hugo [31]) è nascosta la impalpabile nostalgia del suo contrario, del desiderio dell’avvento del Fest-Tag che dovrebbe sancire la possibile parousia dell’Assoluto.
Nella kénosis (tale è l’insegnamento di Paolo di Tarso) si profila la Gloria; nello “spappolamento” dell’umano è presente la felicità del divino. Ma la gloria di cui qui si parla non è soltanto quella dei cieli; si tratta di una prospettiva assolutamente mondanizzata, né è possibile pensarne una diversa.
Il saltimbanco si limita ad apparire, non ad essere: il suo agire è reale, concreto, anche se simula ciò che non è. Come l’attore sul palcoscenico, il clown non ride di se stesso (gli attori che interpretano la pièce “L’assassinio di Gonzago” sono ben lontani dall’essere consapevoli dei sentimenti che susciteranno in Amleto o in Gertrude); come i burattini che don Chisciotte fa a pezzi perché non è più in grado di riconoscere la differenza tra realtà e finzione, così gli attori sulla scena sono puro dominio dell’apparire, fantasmi in carne ed ossa, personae.
Allo stesso modo, i Pierrot e i pagliacci del circo sono capaci di far ridere esibendo la loro corporeità senza che la loro anima intervenga. In bilico tra superficie e profondità, il loro sogno è quello di non essere mai ricondotti a sé: la loro arte è tutta nell’equilibrio tra l’ammicco e l’identificazione, nell’immedesimarsi senza crederci,nella capacità di distanziarsi da se stessi.
Tale è la natura del Sublime: essere a distanza e, tuttavia, partecipare; identificarsi e, nello stesso tempo, rimanere lontani. Il poeta romantico non sarà mai un vero saltimbanco: la sua ironia è poco credibile perché è troppo auto-lesionista.
Per questo motivo, gli “antenati” dei Pierrot sono affiliati, dice Starobinski, “par la main gauche”: credono nella propria verità e si attengono al loro compito.
Essi esprimono una gioia di vivere che non stingono nella melanconia esistenziale del clown – il fool shakespereano, la Follia elogiata a Erasmo da Rotterdam, i Pantalone dei Balli di Sfessania di Callot, il nipote di Rameau descritto da Diderot e illuminato di luce radente dallo Hegel della Fenomenologia dello spirito e, soprattutto, il Socrate mascherato da Sileno della tradizione rinascimentale non sono vittime del male oscuro di vivere.
Soltanto il Socrate “ironista” di Kierkegaard sarà, a tutti gli effetti, simbolo autentico della verità che può essere detta soltanto en saltimbanque (32).
Il pagliaccio del circo è, dunque, mitopoietico: serve a costruire vertiginose piramidi di sogni sulla base miserabile dell’esistenza quotidiana. Dal Romanticismo all’Espressionismo, da Baudelaire a Wedekind, da Blok ad Ejženstejn, il modello rimarrà lo stesso, anche se il retaggio del Sublime dopo la parabola romantica, sceglierà altre forme per mostrare la sua presenza sottaciuta.
In altre parole, il clown di Théophile Gautier è sublime, il Pierrot della commedia Balagančik (33) o il Buffone in Il Re sulla piazza (34) (sono i titoli dei più importanti drammi lirici di Aleksàndr Blok) non lo sono.
Il fatto è che se l’”uomo sul filo”, l’acrobata in bilico tra vita e morte conserva la necessaria distanza per realizzare il disegno della propria superiorità, il personaggio clownesco che informa di sé la messinscena di Wedekind o di Blok crede nella realtà del suo grido, nella potenza della sua espressività, nella forza dilacerante del suo destino.
Il circo è onnicomprensivo: il dolore si annida nella risata, il terrore è sospeso insieme all’acrobata sul trapezio, la natura selvaggia si presenta al pubblico con le sue credenziali di civiltà.
Ma nel serraglio della Lulu (35) (come nella baracca dei saltimbanchi di Blok) non c‘è la riflessione sulla potenza del soggetto, né il trionfo della ragione sulla paura. Manca quel “secondo tempo” dell’immaginazione che si è visto contraddistinguere il “Sublime gotico”.
Il primato dell’occhio uccide la forza della meditazione del Soggetto su se stesso (36). La natura della visione è esibita in modo tale da mutare “il mistero in cinematografo” (come diceva Andrei Bely delle opere teatrali dell’amico Aleksándr Blok). Lo stesso precipitare del teatro in momento multiplo di rappresentazione multi-mediale rivela la non-sublimità della lontananza dallo spettatore, non dello spettatore.
Per questo stesso motivo, come disse una volta Franz Kafka a Gustav Janouch e come questi riporta nei suoi Colloqui, “il cinema mi impedisce di vedere” (e come aveva ragione !); ciò che è troppo vicino subisce la stessa sorte di ciò che si finge di collocare lontano, in entrambi i casi.
Il Sublime è mistero.
O, meglio, si tratta di un mistero che si rivela solo attraverso le sensazioni e le impressioni provate mediante un rapporto di coinvolgimento con l’oggetto; attraverso una forma di rappresentazione “a distanza” dell’intimo sommovimento dell’Io.
L’Espressionismo (in particolare quello tedesco dei Wedekind e dei Toller[37]) brucia la possibilità della meditazione sulla forma imponendosi come tale; il circo in cui è introdotta la Lulu di Wedekind non differisce molto (come si è potuto leggere in nota) non differisce molto dal cabaret di infimo ordine in cui, alla fine della sua parabola di decadenza e morte, sprofonda il professor Un-rat in L’Angelo Azzurro (38): eppure, i caratteri approntati per i lettori sono toto coelo diversi.
Lulu è indifferenza naturale costretta a reagire con il precipitato artificiale della vita in società; Raat è costruzione artificiale che si rende conto, tragicamente (id est grottescamente), di essere di natura soggetta alle pulsioni che comunemente la caratterizzano (la sua educazione formale umanistica e pedantesca non essendo che l’esasperato risvolto dell’”olimpicità” attribuita a Goethe).
La connessione tra poetica espressionistica e sopravvivenza del Sublime salta ad opera della virtù descrittiva che Wedekind prima, Toller poi metteranno in scena.
L’Espressionismo comporta una de-soggettivizzazione, una privazione di sensibilità per il soggetto che lo priva del pathos morale dello scatto in avanti, della furia scatenata di un divenire che si fa strada suo malgrado (nonostante, cioè, le intenzioni, le direttive e le aspirazioni del suo ideatore – ciò accade, ad esempio, in Heinrich Mann, come si è già visto, ma anche nella cultura francese ad esso contemporanea che presenta una dimensione del Sublime che precipita nel Grottesco (è il caso di Louis-Ferdinand dit Céline [39]) e di Grottesco che si riconfigura come Sublime (è il caso di André Malraux (40), di Pierre Drieu de la Rochelle (41), di Jean Genet [42]).
Se quello che Genovese scrive fosse vero, e cioè che:
«Il circo abolisce quinte e proscenio, ma soprattutto abolisce la rettilineità dello sguardo a teatro. Se il pubblico del teatro ha l’occhio inchiodato in una visuale da angolo piatto, l’occhio del circo è invece l’occhio totale. Per esso nulla è nascosto: le carte sono tutte scoperte ma come nel gioco di un prestigiatore» (43), l’equazione tra poeta e clown, tra artista e saltimbanco sarebbe data come falsa in partenza.
La capacità mimetica dell’artista del circo sarebbe soltanto la distanza di sicurezza dello spettatore. Di conseguenza, come continua Genovese, certamente prendendo Brecht troppo sul serio:
«L’occhio totale s’appropria di tutto ciò come di una cosa sua, facendone il suo proprio orizzonte. Ogni realtà s’alimenta di finzione, ogni soggetto di lontananza. Così il pubblico è costituito in soggetto alimentando di finzione il suo occhio lontano. Comprendiamo allora il significato del di stanziamento, come pure la ragione dell’amore di Brecht per Wedekind» (44).
Ma quello che non si comprende, allora, è come possano darsi insieme soggetto e oggetto del di stanziamento stesso, se ciò che costituisce la sostanza della presa di distanza è il soggetto stesso.
Quello che va bene per la teoria epica del teatro di Brecht (e che ha bisogno di un bel po’ di deologia – e di poesia lirica – per riempire il soggetto, altrimenti esso si svuoterebbe troppo presto, lasciandosi andare e appagandosi come Baal, il personaggio della sua prima opera giovanile, di quel “prodigio immenso” che è il cielo “giovane e nudo” – come è scritto nel Cantico dell’ uomo Baal [45]) non basta per il piroettare cinico e lirico insieme che contraddistingue la Stakkato-Technik di Wedekind. Brecht, indubbiamente, ne amava la forma, non tanto lo stravolgimento grottesco (in caso contrario, l’epos della trasformazione sociale sarebbe stato inflitto al pubblico come una variante patetica del “dramma sociale” e i modelli scelti sarebbero stati il Gerhard Hauptmann de I tessitori o lo Ibsen di Un nemico del popolo, non il teatro Nô o il Lustspiel).
Da questo punto di vista, ha forse avuto ragione Friedrich Dürrenmatt nel sostenere, nel suo discorso di accettazione del Premio Schiller del 1959, che in Brecht può essere individuata “la forma più radicale del poeta sentimentale” (46) ed a contrapporre alla Vita di Galilei di quest’ultimo il proprio dramma I fisici (47).
Ma non è tanto la natura “sentimentale” della didattica brechtiana del teatro ad essere in questione quanto la natura “circolare” del circo. E’ vero che la visione del “più grande spettacolo del mondo” (come titolava un famoso film di Cecil B. DeMille del 1952) avviene attraverso un colpo d’occhio totale, ma è altrettanto vero che il di stanziamento che esso produce non si verifica da parte del pubblico (che tutto guarda e a tutto applaude) ma da parte dell’attore in scena.
Ciò appare verificato proprio nel contesto specifico di ciò che parrebbe (paradossalmente) essere il suo contrario: proprio da quel primo piano cinematografico che l’Espressionismo in teatro aspirerebbe a riproporre tramite la già citata “tecnica dello staccato” (teorizzata, ad esempio, dal “teatro politico” di Erwin Piscator [48]).
Infatti, proprio il primo piano o il primissimo piano o il dettaglio non sono il regno dello straniamento – sono, invece, come conferma la lacrima di Lillian Gish che inaugura con Griffith il cinema moderno (49), proprio il luogo del melodramma, del patetico, dell’enfasi nobile dell’immagine che sovrasta e de-limita il Sublime del discorso.
4. Baudelaire e la metamorfosi del poeta
Bisognerebbe continuare a lungo e invece non si può sovraccaricare un’argomentazione che, per sua stessa natura, è già fin troppo ricca delle determinazioni del concetto.
Se il circo, in epoca romantica, aspira alla sua dimensione poetica e ad essere l’allegorico e minaccioso redoublement dell’attività artistica, il clown è, inevitabilmente, la facies melanconica dell’artista ed i suoi contorni coincidono con quelli, provocatori e vittimistici, dello scrittore “autentico”. Di ciò bisognerà rendere conto ora.
Il buffone, come il poeta, è colui cui è demandata la Verità ed è costretto a rivelarla al mondo, con tutto il carico di sofferenze, di derisioni, di ostracismi che questo comporta: il fool (50), il clown, l’artista sono tutti rappresentazione figurale (per dirla con lo Auerbach di Mimesis [51]) dell’antico capro espiatorio della tragedia antica (se si presta fede alla ricostruzione storica di Aristotele (52) confortandola con l’opinione di Walter Burkert (53) e di René Girare[54]).
Il punto di snodo è presto ritrovato. Nel 1842, Théophile Gautier scrive un articolo (“Shakespeare au Funambules”) in cui collega Pierrot ad Amleto.
Il malinconico principe danese è apparentato al sognatore patetico ed esangue innamorato della Luna. Ma non si tratta soltanto di questo (un aspetto importante e singolare della fortuna di Shakespeare in età romantica); chiedendosi chi siano gli autori degli spettacoli prodotti al Théâtre des Funambules, Gautier risponde:
«Personne ne les connaît ; on ignore leurs noms, comme ceux des poètes du Romancero, comme ceux qui ont élevé les cathédrales du Moyen Âge. L’auteur de ces merveilleuses parades, c’èst tout le monde, ce grand poète, cet être collectif qui a plus d’esprit que Voltaire, Beaumarchais ou Byron» (55).
L’apoteosi del clown è la sua capacità aerea, la sua leggerezza, la sua velocità di esecuzione e di rappresentazione; la féerie è una delle forme più rappresentative dello spirito (56), un sublimarsi della pesantezza in proiezione di volo, il sogno dell’ “insostenibile leggerezza” della poesia.
La meraviglia di Gautier nasce dallo stupore per la perfezione dei corpi in movimento, per il modo in cui capacità muscolare e rivelazione del bello si mescolano e si intersecano durante lo spettacolo. L’acrobata, infatti, è qualcosa di più di quello che ogni altro uomo potrebbe rappresentare: è l’incarnazione della gloria terrena. Il circo è trasformato in una sorta di tempio della bellezza, di agone tra fragilità e potenza, tra dignità e virtuosismo.
Théodore de Banville canterà questa speranza in una raccolta di Odes funambulesques del 1857, con i suoi versi, l’ascesa al Parnaso del clown raggiunge il suo climax:
« […] Mas qu’il soit / Un héros sublime ou grotesque; / O Muse! qu’il chasse aux vautours, / Qu qu’il daigne faire des tours / Sur la corde funambulesque, / Tribun, prophète ou baladin, / Toujours fuyant avec dédain / Les pavés que le passant foule, / Il marche sur les fiers sommets / Ou sur la corde ignobile, mais / Au-dessus des fronts de la foule».
Nei suoi versi del resto mediocri, Théodore de Banville, certo più famoso per essere stato lo zimbello di Rimbaud in un testo celebre che per la propria originalità (57), sembra aver intravisto (anche se incertamente e in maniera un po’ balbettante) l’essenza della poesia del Moderno; incespicando e ripetendo i luoghi comuni dello stile romantico attardato cui si aggrappa, egli si è accorto, invece, che qualcosa è cambiato, di come avvenga nei fatti che ormai “tutto ciò che è solido svanisce nell’aria” (58) (come scrive Marx nel Libro I del Capitale).
Eroe sublime o grottesco: i due termini sono ormai intercambiabili.
La derisione che comporta il mestiere di saltimbanco compensa la grandezza dell’atto compiuto; l’importante tuttavia, è sfuggire il contatto con la folla (59) che cammina implacabile sui pavés lastricati di sangue e di miseria della condizione umana.
La vertigine dell’altezza raggiunta è tale da permettere all’artista di ignorare quanto ignobile sia il filo sul quale sta camminando, quanto profondo sia l’abisso, quanto sconvolgenti possano essere le sensazioni che si provano, quanto sia fuggevole l’attimo esaltante dell’ascesa e del trionfo.
Banville intuisce perfino la natura cenotica della fuga verso l‘alto dell’acrobata, il suo parafrasare l’abbandono del mondo in nome di qualcosa di più ideale, di più spirituale:
«De la pesanteur affranchi, / Sans y voir clair il êut franchi / Les escaliers de Piranèse. / La lumière qui le frappait / Faisait resplendir son toupet / Comme un brasier dans la fournaise».
Liberazione dalla pesantezza della vita quotidiana, superamento della vertigine infinita e senza scampo che contraddistingue le Carceri d’invenzione di Giovan Battista Piranesi (60), luminosità e fulgore di un messaggio che rende oscura ogni altra prospettiva, senza speranza ogni altra aspirazione: l’acrobata si libra verso un cielo di assoluta libertà.
La sua capacità di attingere il Sublime è confermata dalla sua prodigiosa leggerezza, dalla sua indifferenza nei confronti del mondo sottostante e per quella meschina ricerca senza senso di un Centro assoluto dalla inutile solidità che lo contraddistingue per definizione.
Simbolo del groviglio disperato e incerto tra giorno e notte, tra crudeltà e sogno, tra slancio verso l’azzurro e rampa per l’abisso, les escaliers di Gian Battista Piranesi rinnovano un mito che a lungo sconvolgerà l’immaginario letterario della cultura romantica francese.
«Plus loin! Plus haut! Je vois encore / Des boursiers à lunettes d’or, / Des critiques, des demoiselles / Et des réalistes en feu. / Plus haut ! plus loin ! de l’air ! du bleu ! / Des ailes ! des ailes ! des ailes ! // Enfin, de son vil échaufaud, / Le clown Santa si haut, si haut ! / Qu’il creva le plafond de toiles / Au son du cor et du tambour, / Et, le cœur dévoré d’amour, / Alla rouler dans les étoiles»
(Théodore de Banville, Le Clown)
Ironia e nostalgica revêrie si mescolano nella descrizione dell’ envol ; le ali che conducono il gioco del Sublime sono lo strumento mediante il quale è possibile librarsi non solo metaforicamente ma anche linguisticamente. E’ nell’espressione plastica che si consuma la modalità narrativa: il ritmico succedersi delle labiali suggerisce a sufficienza la scansione alare del volo; il succedersi cadenzato delle rime baciate dà il senso dell’innalzarsi indomito e liberatorio. Nell’intensa sequenza dinamica che porta il clown dal patibolo alle stelle, il momento cenotico si congiunge alla trasumanazione; l’acrobata si trasforma in poeta, il pagliaccio in artista.
Negando autenticità alla scrittura poetica di Banville, Baudelaire sosterrà che apoteosi troppo facile nega alla vita il contenuto del suo negativo: “Tout l’être intérieur, dans ce merveilleux instants, s’élance en l’air par trop de légèreté et de dilatation, comme pour atteindre une région plus haute” – in questo slancio troppo euforico, l’essenza della poesia si perde perché viene privata della pesantezza della sua necessitata opacità, proprio di quel lato oscuro che pur le appartiene.
Quello che Baudelaire contesta a de Banville non è, tuttavia, il salto verso le eteree altezze della trans-figurazione quanto l’incapacità a coniugarlo con il tuffo all’interno della propria soggettività: il clown delle Odes funambulesques sarebbe certo in grado di salire le rampe di Piranesi ma non di ridiscenderle. Il Sublime baudelairiano si alimenta di entrambi gli estremi; si nutre del fascino un po’ attossicato dell’ escalier de vertige où s’abîme son âme (come si legge nella poesia dedicata a “Le Tasse en prison de Eugène Delacroix” del 1844.
Ma le citazioni della stroncatura dell’opera di de Banville, a causa dell’accento che Baudelaire pone sull’altro aspetto della poesia (il cui compito rimane quello di contemplare anche l’ horrible vie de contention et de lutte) ricordano come l’estasi del funambolo sia inestricabilmente connesso sia alla materialità del corpo che all’inganno della letteratura. La vita è imperfetta, pesante, ristretta dall’angoscia e dalla fragilità degli esseri corporei – fragilità tutta spirituale dove dovrebbe imperare, invece, il vigore e la fisicità.
Il fascino della vita del circo è dato da questa mescolanza: il corpo sembra sciogliersi nelle sue metamorfosi, nelle sue piroette, nelle sue smorfie graziose, nella menzogna del suo belletto, ma resta, al di sotto del suo rivestimento magico, una presenza fisicamente innegabile e inarrestabile, al limite della sostenibilità e della forza di gravità.
Baudelaire se ne rende conto perfettamente: “l’artiste n’est artiste qu’à la condition d’être double et de n’ignorer aucun phénomène de sa double nture » (è questa la conclusione del suo saggio sul riso).
I corpi abitano le anime: conclusione perfettamente mistica, se ci si pensa bene. E mistico vuole essere il compiuto assetto del dandy, il doppio meglio riuscito del poeta.
«Dans la nouvelle que Baudelaire intitule d’un nom de guerre éclatant et frivole, La Fanfarlo, la fascination exercée par l’héroïne résulte des rôles fabuleux dont elle soutient successivement l’illusion parfaite. Pour que le corps de la Fanfarlo exerce tout l’attrait qui la rend désiderable, il faut que, dans l’univers magique de la pantomime, elle développe une multiplicité de personnages» (61).
Donna, circo, danzatrice e maschera si fondono in una metamorfosi teratomorficamente perfetta; l’arena dove i personaggi da baraccone si esibiscono è una nuova epifania delle Wunderkammern (62), dove nani e prodigi della natura, donne barbute o gigantesche si producono in una sorta di eclatante sospensione della normalità. Il circo è il luogo dove il diverso diventa natura, l’impossibile si trasforma nella più facile delle movenze, lo smisurato è ridotto alla più mite dimensione umana. Non è certamente un caso, nella perfetta sincronizzazione delle fasi in cui è articolata la sequenza delle Fleurs du Mal, che al sonetto XVIII (L’Ideal) segua immediatamente il sonetto La Géante e poi ancora la poesia (più lunga, però, delle precedenti) intitolata Le Masque.
Questi tre componimenti articolano una sorta di ars poetica che esprime, nei suoi cesellati versi scanditi, le convinzioni baudelairiane sulla natura “doppia” del Sublime:
«Ce qu’il faut à ce coeur profond comme un abîme / c’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, / rêve d’Eschyle éclos au climat des autans ; / ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange, / qui tors paisiblement dans une pose étrange / tes appas façonnés aux bouches des Titans»
(L’Ideal, vv. 9-14)
La bellezza “ideale“ è profonda come la notte in cui il delitto trova il suo ambiente più adatto, è l’abisso dove affondare fino all’annientamento, è il non-finito michelangiolesco (non finito perché in-finito…) che alletta per la sua magistrale alterazione della natura. L’ abîme del cuore diventa la profondità della forma.
«Du temps que la Nature en sa verve puisante / concevait chaque jour des enfants monstrueux, / j’eusse aimé vivre auprès d’une jeune géante, / comme aux pieds d’une reine un chat voluptueux
[…]
parcourir à loisir ses magnifiques formes ; / ramper sur le versant de ses genoux énormes, / et parfois en été, quand les soleils malsains / lasse, la font s’étendre à travers la campagne, / dormir nonchalamment à l’ombre de ses seins, / comme un hameau paisible au pied d’une montagne»
(La Géante, vv. 1-4 ; 9-14)
La Natura è feconda generatrice di mostri ; eppure, queste forme che non hanno nulla del concetto dell’umano sono più belle, più fascinose, più seducenti della Civiltà delle beautés d’hôpital (L’Idéal, v. 6).
La giovane gigantessa, creatura da circo, reperto quasi preistorico (ne fa fede una lunga tradizione di seduzioni avvertite dai Mémoires di Giacomo Casanova a Il Casanova di Fellini), sogno nostalgico dei primordi, è il simbolo di una bellezza che non può più essere connotata dal languore esangue e dalla mancanza di passione dell’ inutile beauté (63) ad essa contemporanea.
La Géante è la rappresentazione sessualizzata della Natura e la conseguente riduzione di essa a pura corporeità. Rendendo mostruoso ciò che è naturale, lo si riconduce nel recinto del circo (come solitamente si fa con le bestie feroci tradotte dalla giungla nera negli zoo).
La gigantessa, fenomeno da baraccone, è l’esorcizzazione di quelle pulsioni che il regno della Civiltà dissimula a malapena – è anch’essa l’altra faccia della cultura delle buone maniere e dell’”accasermamento” del desiderio (Norbert Elias).
Il meraviglioso contenuto nella metafora della gigantessa trasformata in montagna si palesa, pacificato, nella sua riduzione a montagna che ricorda una donna. Il terribile è domato (così come avviene, ancora una volta, per i leoni nella gabbia del circo) e ridotto a misura d’uomo. Così la spaventevole e smisurata bellezza della montagna, il cui traguardo sembra irriducibile alla fragilità umana, è trasformata nella bellezza muliebre più tranquilla ed estenuata.
Il Sublime viene addomesticato: il mostruoso ritorna ad essere normale, l’era geologica risulterà quella del Moderno dispiegato e trionfante. La minaccia che essa presenta è tenuta a distanza di sicurezza. Come spesso gli è accaduto in casi simili, Guido Almansi ha colto il sostrato concreto (e concettuale) dell’esorcizzazione baudelairiana:
«La Géante, nel momento stesso in cui la lassitudine estva la induce a distendersi attraverso la campagna, diventa campagna (come la Nuda Aestas di D’Annunzio che cade nella sabbia marina), i seni diventano montagne; inoltre, e qui sta il dato sorprendente, il poeta diventa un hameau paisible. Il paragone è insolito: a questo punto ci si aspetterebbe l’idea di un animale rannicchiato nella zona d’ombra ai piedi della montagna. La parola hameau poi non appartiene al lessico baudelairiano, meno ancora l’espressione hameau paisible (64), una notazione di carattere paesistico e moralistico a un tempo che si deve ammettere come eccezionale nell’opera di Baudelaire. Se colleghiamo poi l’ hameau paisible con il dormir nonchalamment del verso precedente a cui si riferisce, il tutto suggerisce un senso disteso e sereno di una natura idillicamente e sensualmente intesa che mi sembra unica nell’universo poetico baudelairiano. Che cosa è avvenuto? La spiegazione più plausibile ci sembra la seguente: l’intervento di una larga visione paesistica ha trasferito il centro d’interesse dal caso teratologico al paesaggio naturale a cui la Géante viene rassomigliata. Non è più la Géante che è grande, immensa come una montagna, è la montagna che ha la forma anatomica di una Géante» (65).
Le “umide nebbie” che calano sugli occhi della gigantessa (al v. 8 della poesia) sono un’implicita verifica dell’assunto precedente. Se la trasformazione della donna in montagna non avvenisse, il poeta non potrebbe essere né il “gatto voluttuoso” del verso 4 né il “quieto borgo” del verso 14.
La bellezza è, infatti, in Baudelaire, sempre apparenza, inganno, maschera: dietro il profilo perfetto della Donna, si nasconde il suo contrario che è il dolore e la noia di vivere (66).
Il poema che segue La Géante ne spiega l’allegoria, come quello ancora successivo (l’ Hymne a la Beauté – il XXI delle Fleurs du Mal) ne definisce il destino.
Bellezza ed Orrore si rincorrono e si ritrovano nel contatto che genera entrambi: la donna, simbolo vivente del bello naturale, è, contemporaneamente, il repertorio del male possibile.
La Maschera che racchiude il trionfo della bellezza descrive, aquila ancipite, la natura scissa e dolorosa dell’armonia:
«Contemplons ce trésor des grâces florentines; / dans l’ondulation de ce corps musculeux / l’Elégance et la Force abondent, sœurs divines //
[…]
A cet être doué de tant de majesté / vois quel charme excitant la gentilesse donne ! / / Approchon, et tounons autour de sa beauté. // O blasphème de l’art ! O surprise fatale ! / la femme au corps divin, promettant le bonheur, / par le haut se termine en monstre bicéphale ! // – Mais non ! Ce n’est qu’un masque, un décor suborneur, / ce visage éclairé d’une exquise grimace, / et, regarde, voici, crispée atroement, / la véritable tête, et la sincère fasce / renversée à l’abri de la face qui ment»
(Le Masque, vv. 1-3 // vv. 14-24)
La “statua allegorica“ di Ernest Christophe cui Baudelaire fa riferimento si intitolava, per l’appunto, La Condition humaine: belletto e mascheratura, décor e charme sono la falsa apparenza della Bellezza, sono l’immagine rovesciata della verità, sono l’impossibile tentativo di dimenticare (e far dimenticare) l’ état humain del dolore e dell’angoscia.
Il flanc d’athlète che la statua esibisce, il suo corpo muscoloso non sono che vani baluardi contro la vita che muore; la bellezza, la grazia, la forza e l’eleganza si sbriciolano così, all’improvviso, nell’inutile attesa del domani.
L’armonia regge il “corpo divino” che sembra essere in grado di superare ogni ostacolo, ma, atrocemente, il suo rovescio rivela la disarmonica impotenza di quella stessa corporeità che voleva essere la promessa di voluttà infinita.
Cielo e Inferno si confondono; dolore e piacere si giustappongono e si alternano in una delirante altalena di sensazioni (la prospettiva è certo spirituale, non fisica anche perché, per Baudelaire, la sofferenza fisica è infinitesima al confronto di quella morale e lo stesso vale per il piacere sentito e subito):
«Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme, / ô Beauté ? Ton regard, infernal et divin, / verse confusément le bienfait et le crime //
[…]
Tu marches sur des morts, Beauté, dont tu te moques ; / de tes bijoux l’horreur n’est pas le moins charmant, / et le Meurtre, parmi tes plus chères breloques, / sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement»
(Hymne a la Beauté, vv. 1-3 // vv. 13-16)
Il doppio profilo della Bellezza comprende orrore e magnificenza, crimine e bontà, morale e indegnità ; la sua danza armoniosa induce ai più nefandi tradimenti e agli atti più gravi ed abietti, eppure la luce che la circonfonde è salvifica, rende gli uomini capaci di aprirsi la strada verso l’Infinito. Bellezza e Male, dunque, si integrano nella corporeità (67).
La malattia di cui Baudelaire soffre è quella di essere assillato dalla materia (68), così come il clown o la danzatrice sono vittime della pesantezza della gravità.
Il paradosso nasce dal fatto che la bellezza è fatta di carne e non soltanto di belletto – la danseuse è fornita di un corpo che continuamente fa valere i suoi diritti.
Il declino e la caduta della Donna come artista sono i soggetto di La Fanfarlo, novella terribile e rappresentativa del rapporto conflittuale che, in Baudelaire, si instaura tra femmina e dandy (69), ovverossia tra Bello e Sublime:
«Talvolta la Fanfarlo gridava e rideva forte verso la platea alla fine d’uno slancio alla ribalta; aveva il coraggio di camminare mentre danzava; mai indossava una di quelle insipide vesti di mussola che fanno vedere tutto e niente indovinare. Le piacevano le stoffe rumorose, le sottane lunghe, scrocchianti, pagliettate, zincate, che voglion essere sollevate molto su da un ginocchio vigoroso; i corpetti da saltimbanchi le piacevano, e ballava non già con boccole, ma con pendenti alle orecchie, oserei quasi dire lumiere» (70).
Samuel Cramer, poeta romantico e ingenuo, si illude di poter conquistare Madame de Cosmelly, strappando, per compiacerla, la danzatrice e mima Fanfarlo al marito della signora che se ne è invaghito e, di conseguenza, trascura i suoi doveri coniugali nei confronti della propria legittima consorte. E’ per amore di quest’ultima che Cramer comincia a frequentare il teatro dove la Fanfarlo si esibisce. Assistendo alle rappresentazioni in cui l’attrice-mima trionfa, Samuel se ne innamora a sua volta (o, meglio, si innamora delle sue apparenze delle sue apparizioni):
«Alcuni giorni appresso la Fanfarlo faceva la parte di Colombina in un’ampia pantomima composta per lei da certa gente di spirito. Vi compariva in un piacevole seguito di metamorfosi nelle persone di Colombina, di Margherita, di evira e di Zeffirina, a ricevere colla massima allegria i baci di molte generazioni di personaggi presi in prestito da molte letterature e regioni. Un grande musicista non aveva disdegnato di scrivere una partitura fantastica e conveniente alla bizzarria del soggetto. La Fanfarlo fu volta a volta decente, fantasiosa, folle, giocosa; sublime nell’arte sua e attrice colle gambe tanto quanto ballerina con gli occhi»(71).
Il poeta romantico si innamora della protagonista della pantomima – passa cioè da un’illusione (l’amore per Madame de Cosmelly) ad un’altra.
D’altronde, illudersi è la sostanza della sua natura: votato al paradosso e alla pigrizia sostanziata di brevi momenti di attività, infaticabile inventore di ciò che non si affanna minimamente a trovare, il suo ingegno è dedito alla scienza di pensare (e realizzare) l’impossibile.
D’altro canto, la Fanfarlo è perfetta nella sua capacità di fingere la verità; per essa, infatti, non c’è alcuna differenza tra recitazione e condotta quotidiana, tra sentimento vissuto autenticamente ed interesse personale:
«La danza può svelare quanto c’è di misterioso nella musica, col merito, per di più, d’essere umana e palpabile. La danza è la poesia con braccia e gambe, è la materia graziosa e terribile animata, imbellita dal movimento. – Tersicore è una Musa del Mezzodì; presumo che fosse molto bruna, e che sovente abbia messo i piedi fra il grano dorato; ogni suo moto, pieno di cadenza esatta, è un divino motivo statuario. Ma la cattolica Fanfarlo, non contenta di rivaleggiare con Tersicore, chiamò in aiuto tutta l’arte di più moderne divinità. Le brume avvolgono forme di fate e d’ondine meno vaporose, meno indolenti. Fu un capriccio di Shakespeare e una buffoneria italiana» (72).
La danseuse vive della sua rappresentazione; è sostanzialmente priva di quei caratteri umani che contraddistinguono ogni donna.
In rapporto vivente con le Muse, essa dovrebbe rivelarsi androgina o del tutto asessuata e, come tale, infatti, il poeta l’immagina. La sua delusione di amante è manifesta quando la Fanfarlo, innamoratasi di lui, ritorna simile alle sue consorelle femmine e si rivela una donna come tutte le altre:
«Quale uomo non vorrebbe, pagando anche con la metà dei suoi giorni, vedere il sogno, il proprio sogno vero, stare davanti a lui senza veli; il fantasma adorato della sua immaginazione far cadere ad uno ad uno tutti i vestiti destinati a proteggerlo dagli sguardi del volgare? Ma ecco Samuele, preso da un estro bizzarro, che si mette a strillare come un bambino viziato: “Voglio Colombina, rendimi Colombina; ridammela quale m’apparì la sera che mi fece impazzire col suo costume di fantasia e con quel corpetto da saltimbanco!”» (73).
La verità dell’Arte è fatta di carne e di sangue; adorandone le forme fenomeniche, si finisce per inginocchiarsi davanti ad un feticcio (74).
Il poeta si illude di vivere in un mondo fatto di letteratura, di libri, di versi e di rime ben composte ma, alla fine, l’artificio stinge nel pallore della morte di fronte alla conoscenza della realtà della vita.
Samuel Cramer è malato di letterarietà e la sua infermità è la stessa che affligge gran parte dei suoi contemporanei; la natura gli sembra malfatta e ciò che è artificiale gli appare di gran lunga più bello di quello che non è stato manipolato da mani umane. Vittima di se stesso e della propria aspirazione al trionfo dell’immaginazione pura, rischia di essere padroneggiato da quella stessa materialità che aspira a negare e a sopprimere.
«Per quanto Samuele fosse di un’immaginazione depravata, e forse proprio per questo, l’amore in lui era una faccenda del ragionamento più che dei sensi; prima di ogni altra cosa, ammirazione ed appetito del bello; e riguardava la riproduzione come un difetto dell’amore, la gravidanza come una malattia dei ragni. Non so dove, ha scritto: gli angeli sono ermafroditi e sterili. – Egli amava nel corpo umano la specie di un’armonia materiale, di un’architettura bella, e, in più, movente. Tale materialismo assoluto non era lontano dal più puro idealismo. Ma siccome nel bello, causa dell’amore, v’erano, secondo le parole sue, due elementi: la linea e il richiamo, – e siccome tutto questo spetta alla sola linea, – il richiamo, per quella sera almeno, era il rossetto.La Fanfarlo dunque riassumeva per lui linea e richiamo…» (75).
E’ lo stesso vizio di forma che si potrà riscontrare successivamente negli altri cantori dell’Angelo sotto veste di Buffone (nelle geometriche ironie di Jules Laforgue oppure nella rêverie all’ennesima potenza di Gérard de Nerval oppure, ancora, nelle tessiture infinite di parole dei versi di Stéphane Mallarmé): l’opacità della materia che si traveste del costume multicolore di Arlecchino trasformando la carne in spirito e lo spirito in apoteosi sensibile della carne.
Se si è insistito tanto su La Fanfarlo è perché si tratta di un’opera paradigmatica; in essa sono riassunti, nella condensazione che contraddistingue la poesia, tutti i temi finora analizzati.
L’amore di Samuel Cramer per il maquillage trionfa su quello del signor de Cosmelly per il corpo della danseuse, ma la vittoria finale è quella della ex-attrice e mima che diventa, nelle pagine finali della novella, una moglie quasi perfetta per il poeta di cui si è innamorata:
«Samuele conobbe ogni tortura della gelosia, e la bassezza e la tristezza in cui ci getta la coscienza d’un male incurabile e organico, – in una parola, tutti gli orrori del matrimonio viziato che si chiama concubinaggio. – Quanto a lei, ingrassa di giorno in giorno; s’è fatta una beltà pingue, forbita, lustrata e furba, una sorta di Lorette ministerielle» (76).
La donna è ritornata una donna, placida e serena nel suo ruolo riconquistato. Il poeta è diventato un marito. Nessuno dei due è più un artista o un angelo. E tutto avviene secondo copione.
La rifrazione a cui è soggetto il Sublime non è qui tanto l’Orrore e il Grottesco della morte o della deformazione ma è lo squallore del quotidiano in cui al posto della sublimità si fa largo il suo opposto. Il volo dell’Angelo è l‘altra faccia della stasi del borghese – eppure per entrambi è dato il sogno del Sublime.
NOTE
(1) J. L. BORGES, “Ecclesiaste, 1-9” in La cifra, trad. it. a cura di D. Porzio, Milano, Mondadori, 1988 (2°ed.), pp. 35-37.
(2) Come scrive lo stesso Hegel: “La prima purificazione radicale e la prima esplicita separazione fra ciò che è in sé e per sé e la presenza sensibile, cioè la singolarità empirica dell’esterno, va cercata nella sublimità, che innalza l’assoluto oltre ogni esistenza immediata, realizzando così la liberazione dapprima astratta, che è nondimeno la base dello spirituale. Infatti il significato così sublimato non è ancora concepito come spiritualità concreta, ma tuttavia è considerato come l’interno in sé essente e poggiante, incapace per sua natura di trovare la sua vera espressone in fenomeni finiti. Kant ha fatto una distinzione molto interessante fra belle e sublime, e quel che egli ha detto nella prima parte della Critica del giudizio (§§ 20 sgg.) conserva sempre il suo interesse, nonostante ogni prolissità e la riduzione, posta a base, di tutte le determinazioni al soggettivo, alle facoltà dell’animo, l’immaginazione, la ragione ecc. Questa riduzione deve essere ritenuta esatta nel suo principio generale in rapporto a quel lato per cui la sublimità, come dice Kant, è contenuta non nelle cose della natura ma solo nel nostro animo, inquantoché noi siamo coscienti della nostra superiorità sulla natura in noi e quindi anche fuori di noi. […] Il sublime in generale è il tentativo di esprimere l’infinito senza trovare nel regno dei fenomeni un oggetto che si mostri adeguato a questa rappresentazione. L’infinito, proprio perché è per sé posto fuori dell’intero complesso dell’oggettività e interiorizzato come significato visibile e privo di forma, rimane inesprimibile nella sua infinità e superiore ad ogni espressione per mezzo del finito“ (G. W. F. HEGEL, Estetica, ed. it. a cura di N. Merker, trad. it. di N. Vaccaro e N. Merker, Torino, Einaudi, 199311, pp. 409-410).
(3) J. CONRAD, La linea d’ombra, trad. it. di F. Arcangeli e G. Festi, Milano, Bompiani, 19802, p. 11.
(4) Cfr. R. BODEI, Le forme del bello, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 83-84: “Una volta crollato il rassicurante ordine dell’universo tolemaico centrato sulla Terra e sull’uomo, il sistema copernicano appare come una minaccia, che spinge l’uomo – pascaliano “re spodestato” – all’esilio o alla prigione in un “carcere buio”, posto nella “più profonda sentina” dell’universo. La sfida al cosmo non assume più il carattere di una orgogliosa esaltazione che sminuisce il valore del mondo di fronte alla sconfinata grandezza del nostro pensare e sentire. Subentra la paura, la percezione dell’incommensurabile inadeguatezza dell’uomo rispetto a un ordine che, nella meccanica celeste e terrena, si comprende ormai secondo perfette leggi universali, ma di cui non si afferra invece il senso che eventualmente ha per noi. La “ferita narcisistica” subita dalla specie umana quando viene relegata alla periferia del “creato” è risarcita solo in parte dalla maggiore attenzione a questo mondo promossa dalle arti, dalla nascente riflessione estetica e dalle teorie scientifiche, che mostrano, come non mai, la piena razionalità del mondo fisico e, in prospettiva, di quello storico. A partire dal Seicento, scienza e arte sembrano così, a torto, procedere in direzioni divergenti: la prima rende intelligibile la realtà “materiale” (in quanto la matematica si applica ora con esattezza anche alla fisica, la quale cessa così di essere una techne); la seconda, a sua volta, che pare non tenere il passo con la scienza, ne elabora invece i traumi e ne utilizza i risultati, aprendo anch’essa nuove strade al pensiero e alla sensibilità. In questa situazione, la nostra unica dignità è, pascalianamente e kantianamente, quella di sfidare l‘universo, sapendo di essere destinati fisicamente alla sconfitta finale, ma di avere su ciò che ci distrugge una superiorità intellettuale e morale”.
(5) Cfr. J. PAUL (Richter), Il discorso del Cristo morto, trad. it. di B. Bianchi, Milano, SE, 1997.
(6) Il suo emblema è rappresentato dal volto devastato e sublime di Gwynplaine, l’Uomo che ride del romanzo omonimo di Victor Hugo del 1869. “E improvvisamente, in quell’ombra, un raggio di luce colpiva Gwynplaine in pieno viso. Si vedeva sbocciare il mostro dalle tenebre. La commozione della folla era indescrivibile. La risata sorgeva come un sole, tale era l’effetto. Il riso nasce dall’inatteso, e nulla poteva essere più inatteso di quello scioglimento. Lo schiaffo di luce sulla maschera buffa e terribile produceva un’impressione impareggiabile. Tutti ridevano, dappertutto: in alto, in basso, sul davanti, in fondo; gli uomini, le donne, i vecchi, i rosei volti dei bambini, i buoni, i cattivi, la gente allegra, quella triste, tutti; e nella via anche i passanti, che pure non vedevano, udendo ridere, ridevano. E il riso finiva in un batter furioso di mani e di piedi. Calata la tela, si richiamava Gwynplaine con frenesia. Era un successo enorme. Avete visto Vittoria sul caos? Tutti accorrevano a Gwynplaine. Gli spensierati venivano per ridere, i tristi venivano per ridere, le coscienze inquiete venivano per ridere. Una risata così irresistibile che qualche volta poteva sembrare epidemica“ (V. HUGO, L’uomo che ride, trad. it. di C. Marini, Milano, Garzanti, 1976, p. 291). Sul tema del Grottesco in relazione al Sublime per quanto riguarda la scrittura di Victor Hugo, cfr. la buona antologia Sul grottesco, trad. it. e cura di M. Mazzocut-Mis, Introduzione di E. Franzini, Milano, Guerini e Associati, 1990 (contiene la celebre Prefazione alla tragedia Cromwell e alcuni passi del saggio dedicato a William Shakespeare).
(7) Il professor Unrat, ovvero La fine di un tiranno è il titolo di un celeberrimo romanzo di Heinrich Mann meglio noto come L’Angelo azzurro (dal titolo del film che Josef von Sternberg ne trasse nel 1930 e che fu interpretato magistralmente da Emil Jannings nel ruolo di Unrat e di Marlene Dietrich in quello della sua amante-padrona Lola-Lola; un remake del 1959 diretto da Edward Dmytryk con Curd Jürgens e May Britt non conobbe eguale risonanza nell’immaginario collettivo nonostante la buona prova dei due attori). Heinrich Mann ben sapeva che cosa era e doveva essere il Sublime se mette in bocca al suo protagonista una frase del genere: “A questo punto la voce di Unrat si tramutò in una voce da sottosuolo: “Lei non è degno di accostarsi – con la sua misera e insulsa penna – ala sublime figura muliebre di cui stiamo per occuparci. Fuori ! Nello sgabuzzino!”” (H. MANN, Il professor Unrat – L’Angelo azzurro, trad. it. e cura di G. Schiavoni, Milano, Mondadori, 1991, p. 41). Unrat sta rimproverando il suo allievo von Ertzum a proposito di quello che ha scritto su Giovanna d’Arco, la protagonista del celebre dramma di Friedrich Schiller oggetto di un compito in classe). Su Heinrich Mann e il suo destino di scrittore, cfr. il lucido saggio di J. FEST, I maghi ignari. Thomas e Heinrich Mann, trad. it. di M. Bistolfi, Bologna, Il Mulino, 1989. Di un certo interesse sono anche il saggio di F. CAMBI, “L’opposizione arte-vita fra ‘800 ne ‘900 in Heinrich e Thomas Mann”, in “Annali I.U.L.M. di Felte”, 5, 1981, pp. 31-67; la Nota di B. MAFFI alla sua traduzione del romanzo, Milano, Rizzoli, 1953, pp. 5-10; la voce Heinrich Mann contenuta in L. MITTNER, Storia della letteratura tedesca. Dal realismo alla sperimentazione (1820-1970), Torino, Einaudi, 1971, pp. 1039-1049 e il poderoso volume di W. H. SOKEL, Demaskierung und Untergang Wilhelminischer Repräsentanz. Zum Parallelismus der Inhaltsstruktur von “Professor Unrat” und “Tod in Venedig”, Tübingen, Niemeyer, 1976.
(8) R. BODEI, Le forme del bello cit. , pp. 84-85: “La “dignità” (termine che diventerà decisivo nella riflessione morale ed estetica) del pensiero e la nobiltà d’animo non è altro che la dignità del sublime: di fronte alle dimensioni e alle forze oscure del mondo, sono consapevole della mia nullità (di mancare di valore nell’economia dell’universo), del rischio di venire anzi schiacciato e annientato alla loro potenza, di essere una canna piegata da tutti i venti, ma “canna che pensa”. Ed è proprio questo scatto di orgoglio, questo moderno revanscismo del pensiero e dell’umanità contro la natura tutta, che suscita il sentimento del sublime. In quanto conosco la mia insignificanza dinanzi al mondo, la mia grandezza non consiste più nell’aderire mimeticamente al suo ordine, ma nel crearne un altro, nell’istituire un umano “regno dei fini”, difficile e quasi impossibile da governare. Mi accorgo di essere fuori posto, disarmonico e comunque non integrato nel cosmo: vivo così la mia sproporzione immaginando una disperata rivincita. Gran parte dell’estetica barocca e protoromantica è, in effetti, un’estetica della sproporzione, della dismisura, della disarmonia. Rimanda a un ordine, a una proporzione e a un’armonia eventuali, celati, nel migliore dei casi, alla ragione e oscuramente intuibili, invece, attraverso l’arte o la fede in un “Dio nascosto” quale garante del fatto che le cose abbiano, alla fine, un senso. Alle vertigini provocate dallo sprofondare con lo sguardo nell’immensità dello spazio si aggiungono, a partire dalla fine del Seicento, quelle prodotte dalla percezione dell’immensità del tempo, che la geologia scopre analizzando la conformazione di rocce e minerali. Ci si accorge così che la Terra non è stata creata in sei giorni e che sicuramente scomparirà, sebbene non così presto come ritengono i sostenitori dell’Apocalisse. Essa appare infatti il risultato dell’energia, tuttora operante, di immani forze catastrofiche, di cataclismi accumulatisi in milioni di anni. La consapevolezza di questi abissi del tempo provoca uno spavento che non è connesso soltanto alla constatazione della potenza della natura., ma anche a quella della caducità e della fragilità di tutto, compreso l’uomo. Il mondo è immenso, ma finirà; esiste da tanto, ma sarà distrutto. Noi godiamo del discutibile vantaggio di saperlo, mentre le pietre o gli animali lo ignorano. Diventiamo in tal modo coscienti del contrasto tra l’aspirazione immotivabile di ciascuno a una felicità senza limiti e la fine annunciata di tutte le cose. La nascita del sublime moderno è così legata alla coscienza dei destini, insieme intrecciati e separati, della natura e dell’uomo che ha scoperto il “progresso”. Dal punto di vista del sublime, non si tratta tanto di sottomettere e umiliare la natura, ma anche (e per compensazione) di conoscerla e innalzarla nella nostra considerazione, conservandone intatta la potenza e la maestà”.
(9) R. GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca, trad. it. di L. Verdi-Vighetti, Milano, Bompiani, 19812, pp. 51-53.
(10) F. HÖLDERLIN, Poesie, trad. it. e saggio introduttivo di G. Vigolo, Torino, Einaudi, 1967 (2 ed.), pp. 156-157. La dimensione religioso-mistica della scrittura del poeta di Lauffen sul Neckar è confermata dall’uso stesso delle fonti che affiorano da una lettura più in profondità del suo testo. Scrive, infatti, Vigolo nel suo saggio introduttivo: “Ma nello stesso inno Patmos, vicino alle derivazioni sofoclee, pindariche e anche omeriche (Iliade, I, 197), pullulano le citazioni bibliche ed evangeliche: “Die Locken ergriff… (“Li prese ai capelli…”) nella nona strofa, viene da Ezechiele, VIII, 3: “Manus apprehendit me in cincinno capitis mei:… et elevavit me Spirits inter terram et coelum”. Quest’ultima immagine dell’elevazione, del raptus visionario può ben corrispondere a quanto Hölderlin dice nella seconda strofe dello stesso inno, parlando del Genio che lo rapisce nell’aria e lo porta velocissimo verso l’Asia. Nel passo citato di Ezeciele, lo Spiritus: “adduxit me in Jerusalem in visione Dei”” (p. XLVIII). Sulla poesia hölderliniana e la sua pregnanza filosofico-concettuale, cfr. M. PEZZELLA, La concezione tragica di Hölderlin, con un saggio di R. Bodei (L’esattezza delle parabole), Bologna, Il Mulino, 1993 e S. GIVONE, La questione romantica, Roma-Bari, Laterza, 1992, in particolare il capitolo secondo dal titolo “Contraddizione e silenzio” (pp. 41-67).
(11) Lo mostra bene nella sua acuta parafrasi di questo passaggio centrale per la mia analisi, R. BODEI nel suo “Tenerezza per le cose del mondo”. Sublime, sproporzione e contraddizione in Kant e in Hegel” contenuto in Hegel interprete di Kant, a cura di V. Verra, Napoli, Prismi, 1981, pp. 214 sgg.
(12) Sempre da Hölderlin: “Lo spirito del tempo. Già da troppo tu domini sopra il mio capo, / Tu nella oscura nuvola, dio del Tempo! / Troppo furore è intorno e angoscia, ovunque / Io guardi tutto va in frantumi o vacilla. // Ah, come un fanciullo mi affisso al suolo sovente, / Cerco uno scampo da te nella grotta e vorrei, / Stolto, trovare un luogo / Dove non fossi tu che tutto sconvolgi! // Concedimi, infine, o padre, d’affrontarti / Con fermo ciglio! Non hai dunque, per primo, lo spirito / Suscitato in me col tuo raggio, non m’hai / Splendidamente alla vita portato, o padre ! // – Ci germoglia da giovani viti sacro vigore, / In mite aura si fa incontro ai mortali, / Quando silenti errano nel boschetto, / Rasserenante un dio; ma tu, più potente, ridesti // La pura anima nei giovanetti e insegni / Sagge arti agli anziani; solo il malvagio / Si fa più malvagio, per finire più presto, / Quando tu, o Scuotitore, lo ghermisci ” (F. HÖLDERLIN, Poesie cit., p. 37).
(13) M. BROWN, “Kant e i demoni della notte” in “Studi di estetica”, 4-5, 1984 (Atti del Convegno Il Sublime: creazione e catastrofe nella poesia, 30-31 ottobre 1984), a cura di V. Fortunati e G. Franci, p. 160.
(14) M. BROWN, “Kant e i demoni della notte” cit. , p. 161.
(15) M. BROWN, “Kant e i demoni della notte” cit. , p. 163.
(16) Sul concetto di incommensurabile in Kant, Derrida, Victor Hugo e Robert Musil, ho scritto con una certa ampiezza in “Raffigurazioni dell’incommensurabile. Il Mostruoso, il Colossale, l’Inquietante” contenuto nel mio Il Sublime e la prosa. Nove proposte di analisi letteraria, Firenze, Clinamen, 2005, pp. 123-146.
(17) Ne è prova il finale del Principe di Homburg (un dramma del 1811 sfortunato e spesso negletto, mai pubblicato né rappresentato in vita dell’autore perché giudicato “inopportuno” dato il momento storico vissuto dalla Germania): “(Rombo di cannoni. Una marcia. Il castello si illumina) KOTTWITZ Viva, viva il principe di Homburg! UFFICIALI Viva! Viva! Viva! TUTTI Al vincitore della battaglia di Fehrbellin! (un attimo di silenzio) HOMBURG No, dite! E’ un sogno? KOTTWITZ Un sogno, che altro? DIVERSI UFFICIALI Al campo, al campo! TRUCHSS Alla battaglia! MARESCIALLO DI CAMPO Alla vittoria! Alla vittoria! TUTTI Nella polvere i nemici di Brandeburgo!” (H. von KLEIST, Il principe di Homburg, a cura di H. Dorowin, introduzione e traduzione di R. Rossanda, Venezia, Marsilio, 1997, p. 251). Come scrive la Rossanda nella sua Introduzione al testo di von Kleist: “Il principe di Homburg è un’elegia sulla bella giovinezza che duole. Difficile distinguere fra passione e ragione, capire il senso per gli altri, dunque reale, dell’agire che dentro di sé, dunque irrealmente? pare giusto. Perché la legge del cuore induce un ragazzo a sbagliare, Homburg a dover morire? Che ha a che fare con il retto e germanico sentire una legge così “sublime” da diventare “inumana”, come dirà Natalia all’Elettore? Oltre a stare in quegli anni, come sta eternamente fra essere e dover essere, in un esercito in guerra il tema si disegna in figure estreme. Così estrema è la contraddizione che Homburg è sempre colto di sorpresa: “No, impossibile, non è vero”. Non che sia il solo cui la realtà si presenta sfuggente, ma questa che sembra in Kleist la condizione umana mette un giovane con le spalle al muro, lo nega. La maturità ne è il duro apprendistato “ (p. 22).
(18) “Si raccontava che subito dopo la prima scossa la città era piena di donne che partorivano al cospetto di tutti gli uomini; che i monaci correvano intorno col crocefisso in mano urlando che era venuta la fine del mondo; che a un drappello di guardie, il quale pretendeva in nome del viceré che si sgombrasse una chiesa, si era risposto che non esisteva più un viceré del Cile; che nei momenti più paurosi il viceré aveva dovuto eriger patiboli per frenare le ruberie e i saccheggi; e un innocente che si era salvato attraverso una casa in fiamme, era stato acciuffato dal padrone per soverchia fretta e fatto impiccare senz’altro” (H. von KLEIST, “Il terremoto nel Cile”, in I racconti, trad. it. e cura di E. Pocar, Milano, Garzanti, 19792, pp. 150-151).
(19) Meravigliosa e inquietante è la descrizione del terremoto di Santiago del Cile nel racconto omonimo del 1807: “Jeronimo Rugera rimase rigido dal terrore, e come se la sua coscienza fosse stata infranta, ora per non cadere si aggrappò al pilastro doveva aveva voluto morire. Il suolo gli traballava sotto i piedi, le pareti della prigione si spaccarono, tutto l’edificio s’inclinò per abbattersi verso la strada, e il crollo completo fu impedito nella sua lenta caduta soltanto dalla caduta dell’edificio dirimpetto, dimodoché si venne a formare una volta fortuita. Tremando, coi capelli ritti, e con le ginocchia che gli si volevano rompere sotto, Jeronimo scivolò sul pavimento inclinato verso l’apertura che il cozzo delle due case aveva prodotto nella facciata della prigione. Appena fu all’aperto, tutta la strada già scossa crollò per un secondo movimento tellurico. Fuori di sé, non sapendo come si sarebbe salvato da quella generale rovina, correva oltre travi e rottami, mentre la morte lo insidiava da ogni lato, verso una delle più vicine porte della città. Qui crollava ancora una casa che lanciando all’intorno le macerie lo cacciava in una via laterale; là vi erano fiamme che lampeggiando tra nubi di fumo, erompevano dai tetti e lo spingevano in un’altra; lì incontrava il Mapocho straripato che gli andava contro e ruggendo lo trascinava in una terza. Qua v’era un mucchio di ammazzati, là s’udiva gemere ancora una voce di sotto le rovine; qui urli che scendevano da tetti in fiamme, lì lotte di uomini e bestie contro le onde, qui un coraggioso si sforzava di recare aiuto, là un altro, pallido come la morte, alzava le mani tremanti al cielo, in silenzio” (H. von KLEIST, “Il terremoto nel Cile”, in I racconti cit. , pp. 144-145).
(20) E’ quello che si desume dal colloquio finale in carcere tra Federico von Trota e l’amata Littegarda: “Dio onnipotente!” esclamò messer Federico abbracciandole le ginocchia; “ti ringrazio. Le tue parole mi ridanno la vita: la morte non mi fa più paura; e l’eternità, che dianzi si stendeva davanti a me come un mare di sterminato dolore, mi risorge come un regno di mille soli luminosi !” – “O infelice!” disse Littegarda ritraendosi, “ come puoi prestar fede a ciò che dicono le mie labbra ?” – “Perché no?” domandò Federico con ardore. – “Pazzo! folle!” esclamò lei. “ La sacra sentenza di Dio non è stata contro di me? Non fosti sconfitto dal conte in quel fatal duello e non ha egli dimostrato con la spada la verità della sua accusa contro di me?”. – “O dilettissima Littegarda” implorò il camerlengo, “preserva la tua mente dalla disperazione! Ergi come una roccia il sentimento che vive nel tuo cuore, aggrappati a questa e non vacillare, quand’anche la terra e il cielo dovessero crollare sotto e sopra di te! Tra due pensieri che confondono la mente pensiamo il più comprensibile e razionale, e prima che tu ti reputi colpevole, crediamo piuttosto che nel duello che combattei per te io abbia vinto!”. – Dio, signore della mia vita” aggiunse in quel momento coprendosi il viso, “preserva anche l’anima ma dalla confusione! Non credo, e sia salva l’anima mia, di essere stato sconfitto dalla spada del mio avversario, poiché pur buttato sotto la polvere del suo piede sono risorto a nuova vita. Può avere la suprema saggezza divina l’obbligo di svelare e proclamare la verità nel momento esatto in cui sia fiduciosamente invocata? O Littegarda” concluse stringendole una mano tra le sue, “volgiamo in vita lo sguardo alla morte e nella morte all’eternità, e conserviamo la fede salda, incrollabile che la tua innocenza sarà portata, e proprio col duello che ho combattuto per te, alla serena, chiara luce del sole!” “ (H. von KLEIST, “Il duello”, in I racconti cit., pp. 256-257).
(21) “Sulle rive del Havel viveva intorno alla metà del secolo decimosesto un mercante di cavalli di nome Michele Kohlhaas, figlio di un maestro, uno degli uomini più probi e insieme più terribili del suo tempo. – Fino ai trent’anni quest’uomo straordinario sarebbe potuto passare per un modello di buon cittadino. In un villaggio che ancora reca il suo nome possedeva una fattoria dove viveva tranquillamente del suo lavoro. I figlioli che sua moglie gli dava li allevava laboriosi e leali nel timor di Dio; non v’era uno in tutto il vicinato che non avesse goduto della sua benevolenza o della sua equità; insomma il mondo avrebbe dovuto benedire la sua memoria, se in una virtù non avesse ecceduto. Il senso della giustizia lo fece diventare un brigante e assassino“ ( H. von KLEIST, “Michael Kohlhaas”, in I racconti cit. , p. 1).
(22) Dopo la visita del medico che ha rilevato il suo stato di gravidanza, ecco ciò che accade alla marchesa von ***: “Si buttò sul divano, agitatissima. Diffidando di se stessa riandò tutti i momenti dello scorso anno e pensando all’ultimo si considerò impazzita. Infine venne la madre che spaventata le domandò donde derivasse quella sua inquietezza; e la figlia le raccontò quel che il medico le aveva rivelato poco prima. La signora di G… gli diede dello sfacciato, dell’indegno e confortò la figlia nella decisione di mettere il padre al corrente di queste offese. La marchesa assicurò che quello aveva parlato proprio sul serio e sembrava deciso a ripetere la sua folle affermazione anche al cospetto del padre. La signora di G…, non poco spaventata, le domandò se credeva alla possibilità di quello stato. “Piuttosto” fu la risposta della marchesa, “crederei che vengano fecondate le tombe e che un seme si sviluppi in grembo ai cadaveri!” ”Ebbene, mia cara stravagante creatura” disse la signora stringendola al seno, “che cosa t’inquieta? Se la tua coscienza ti assolve, che t’importa il giudizio magari di tutta una consulta di medici? Che il suo sia frutto di errore o di cattiveria, non è indifferente per te? Ad ogni modo è bene che lo diciamo a tuo padre”. “Dio mio!” esclamò la marchesa con un moto convulso, “come posso tranquillarmi? Non ho contro di me la mia stessa sensazione, che m’è fin troppo nota? Se sapessi che un’altra donna prova le mie sensazioni, non giudicherei io stessa che è così?” “E’ orribile!” esclamò la moglie del colonnello. “Cattiveria! Errore!” continuò la marchesa, “che motivi può avere quest’uomo che stimammo fino a oggi, da mortificarmi per capriccio e sfacciataggine? me che non l’ho mai offeso? che l’accolsi con fiducia, col presentimento della mia futura gratitudine? Eppure, come apparve dalle sue prime parole, era venuto con l’intenzione pura e sincera di aiutarmi, non di provocare dolori più atroci di quelli che provavo! E se nella necessità di scegliere” continuò mentre la madre la guardava senza batter ciglio, “dovessi pensare a un errore, è possibile che un medico, sia pur di capacità mediocre, s’inganni in questo caso?”. La signora disse un po’ acre: “Eppure, dev’essere stata o l’una o l’altra” “ (H. von KLEIST, “La marchesa von *** ”, in I racconti cit. , pp. 118-119)
(23) “La frenesia di libertà che ha invaso tutte queste piantagioni spinse i negri e creoli a infrangere i ceppi che li opprimevano e a vendicarsi dei bianchi per molteplici e biasimevoli maltrattamenti, subiti da alcuni tristi elementi fra loro… Specialmente“ continuò dopo un breve silenzio “m’è parsa orribile e singolare l’azione di una giovinetta. Al tempo in cui divampò l’insurrezione, questa fanciulla, di razza negra, era inferma di febbre gialla, scoppiata in città a raddoppiare la sciagura. Tre anni prima aveva servito come schiava un colono di razza bianca, il quale risentito perché non s’era arresa ai suoi desideri l’aveva trattata duramente e poi venduta a un colono creolo. Venuta a sapere, il giorno della ribellione generale, che il suo antico padrone, inseguito dalla rabbia dei negri, si era rifugiato in una stalla vicina, e memore dei maltrattamenti ricevuti, mandò sull’imbrunire un suo fratello a invitarlo a passare la notte con lei. Lo sciagurato non sapendo che la fanciulla era ammalata, né di quale malattia, venne e la strinse fra le braccia con immensa gratitudine, credendosi salvato; ma aveva appena trascorso mezz’ora nel suo letto tra baci e carezze, che quella si levò a un tratto con l’espressione del più freddo e selvaggio furore gridando: ‘Hai baciato un’appestata che porta la morte nel petto; va’ e appicca la febbre gialla a tutti quelli che ti somigliano!’ “ (H. von KLEIST, “Il fidanzamento a San Domingo”, in I racconti cit. , p. 169).
(24) Lo mostra con limpida determinazione e sicura qualità artistica la trasposizione scenica del racconto a cura di Remo Rostagno e Mauro Baliani (Kohlhaas, Perugia, Edizioni Corsare, 2001).
(25) Cfr. ARISTOTELE, Poetica, 1448b-1449a, 4, 34-42:“Ma come anche nel genere serio Omero fu il poeta per eccellenza, – egli infatti fu unico non solamente per la bellezza del suo stile ma anche per il carattere drammatico che seppe dare alle sue composizioni poetiche, – così egli fu anche il primo che rivelò e segnò le linee fondamentali della commedia, poetando drammaticamente non già l’invettiva personale ma il ridicolo puro e semplice. E di fatti il Margite ha con le nostre commedie quello stesso rapporto che hanno con le nostre tragedie l’Iliade e l’Odissea” e 1449°, 5, 31-37: “La commedia è, come dissi, imitazione di persone più volgari dell’ordinario; non però volgari di qualsivoglia specie di bruttezza [o fisica o morale], bensì [di quella sola specie che è il ridicolo perché] il ridicolo è una partizione speciale del brutto. Il ridicolo è qualche cosa come di sbagliato e di deforme, senza essere però cagione di dolore e di danno. Così, per esempio, tanto per non uscire dall’argomento che trattiamo, la maschera comica: la quale è qualche cosa di brutto e come di stravolto, ma senza dolore”( trad. it. di M. Valgimigli, Roma-Bari, Laterza, 1984 (4 ed.), pp. 199-201.
(26) Scrive M. MAZZOCUT-MIS nella sua bella indagine dedicata al Mostro. L’anomalia e il defome nella natura e nell’arte, presentazione di G. Scaramuzza, Milano, Guerini e Associati, 1992, p. 13: “Il mostro, enigma che evoca mistero, stupore, perfino terrore, perde, a partire dal XIX secolo, la sua favolosità conturbante, la sua terrificante meraviglia, per acquistare un nuovo significato e porsi al centro dell’arte e delle speculazioni dei filosofi della natura. Il mostro si cambia d’abito e, anziché sconcertante bizzarria, perversione ingiustificata, portento miracoloso, diventa una presenza incalzante, sebbene enigmatica, che esige una giustificazione intrinseca a quella realtà della quale esso è un elemento costitutivo. Fatto carne vivente e palpitante in un corpo deforme o depersonalizzato nella categoria estetica del grottesco, risvegliato dal fondo dell’animo come deformità morale o scoperto sotto l’effigi di un evento catastrofico e imprevisto, il mostro può rivestire nei suoi molteplici travestimenti un ruolo del tutto inedito e di primaria importanza, un ruolo che gli permette di essere protagonista indiscusso e non sbiadita antitesi del bello, del buono, del regolare, dell’uniforme o dell’armonico. Il mostruoso, che non sia soltanto una contro-figura del bello, può addirittura rappresentare, a certe condizioni, il fattore determinante, che garantisce la possibilità stessa del bello o che assicura il perdurare dell’uniformità nel mondo naturale. Il mostro è l’enigma della vita, calato nella vita stessa; è un principio vitale, incarnato in una forma bizzarra e sconcertante, che mette in evidenza il potere metamorfico e sconvolgente della natura e dell’uomo. Esso sfida la razionalità umana, ponendole di fronte il suo mistero che è il mistero di tutta la creazione. Scoprire le leggi che governano il mostro significa cogliere le leggi che regolano la formazione dell’universo intero”. Sul tema della mostruosità all’interno della discussione sull’evoluzionismo nell’Ottocento tra Lamarck e Darwin, cfr. A. LA VERGATA, L’evoluzione biologica: da Linneo a Darwin, 1735-1871, Torino, Loescher, 1971; G. BARSANTI, Dalla storia naturale alla storia della natura. Saggio su Lamarck, Milano, Feltrinelli, 1979; G. BARSANTI, Teorie dell’evoluzionismo nell’Ottocento, Torino, Loescher, 1980; P. TORT, L’ordre et les monstres, Paris, Le Sycomore, 1980; P. CORSI, Oltre il mito. Lamarck e le scienze naturali del suo tempo, Bologna, Il Mulino, 1983; P. TORT, La raison classificatoire, Paris, Aubier, 1989 e, infine, da ultimo, Desiderio del mostro. Dal circo al laboratorio alla politica, a cura di A. Negri, U. Fadini e C. T. Wolfe, Roma, ManifestoLibri, 2001.
(27) J. STAROBINSKI, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève, Skira, 1970, pp. 9-10).
(28) Su questi temi, cfr. la sintesi storico-metafisica di L. KOLAKOWSKI, Orrore metafisico, trad. it. di B. Morcavallo, Bologna, Il Mulino, 1990.
(29) Come nei versi ilari e feroci con cui Jules Laforgue li descrive nella sua lunga poesia sui Pierrot: “I. E’, su di un collo che rigido emerge / Da una gorgiera inamidata idem, / Una faccia imberbe al cold-cream, / Un’aria da asparago idrocefalo. // Gli occhi sono immersi nell’oppio / Dell’indulgenza universale, / La bocca clownesca ammalia / Come un singolare geranio. // Bocca che va dal buco senza tappo / Gelidamente esilarato, / Alla trascendentale evanescenza / del vano sorriso della Gioconda. // Col cono farinoso ben piantato / Sulla nera calotta di seta, / Fanno ridere le loro zampe di gallina / E arricciano il naso a trifoglio // […] II. Il cuore bianco tatuato / Di sentenze lunari, / Hanno: “Fratelli, bisogna morire!” / Come Evoè e per parola d’ordine. // Quando una vergine trapassa / Seguono il suo corteo, / Tenendo il collo ben dritto / Come si regge un bel cero. // Parte assai faticosa, / Tanto più che non hanno nessuno / A casa che li frizioni / Con un unguento coniugale. // Quei dandy della Luna / A’impomgono, in effetti, / Di cantar “Permettete?” / Alla bionda e alla bruna. // E’ gente, invero, scettica; / E se vi paion vittime, / Qua e là, della Gonna, / Fascia per cicatrizzare, // Siate pur certi che si fingon tonti / Per avere dei seni, / Cuscini di ripiego / Per le loro teste sapienti. // […] III. Come la notte vanno a molestare / Nel fondo dei parchi le statue, / Ma offrendo soltanto alle meno spogliate / Il loro braccio e tutto quel che segue, // Se sono a quattr’occhi con la donna / Han sempre l’aria di fare da terzo, / Confondono l’oggi col domani, / E chiedono Nulla con anima! // Giurano “T’amo!” con un’aria assente, / La voce bianca estatica, / E chiudono le frasi più forsennate / Con certi: “Mio Dio, non insistiamo!” // Finché ebbra (e colta da non si sa quale) / bisogno di luna!). Ella s’oblia / Nelle loro braccia, assai oltre / Le buone convenienze. // IV. Truccati d’abbandono, con le maniche / A salice, essi fan loro giuramenti / Per esser veri troppo veementi! / Poi tumultuano in bianche gighe, // Sbraitando: Angelo ! tu m’hai capito, / Per la vita e per la morte! – e pensano: / Ah! Passarci sopra la spugna! … E in loro non è un partito preso, // Ma, ahimè, l’idea della donna / Che ancora in questo secolo / Si prende sul serio, li torce / In un riso dalle gamme laceranti! // Non gettate loro la pietra, o voi / Fanatici della giarrettiera! / Via, non gettate la pietra / Ai bianchi paria, ai puri pierrot! // V. Bianchi chierichetti della Luna, / E lunologhi eminenti, / La loro Chiesa è aperta a chi capita, / Chiara d’altronde come nessun’altra. // Vanno dicendo, con certe occhiate frolle, / E le maniche arcisacerdotali, / Che questo basso mondo scandaloso / E’ solo uno dei mille colpi di dado // D’un giuoco che l’Idea e l’Amore, / Senz’alcun dubbio anche per conoscere, / La loro propria ragione d’esistere, / Han ritenuto di dare alla luce. // Che del resto nessuno vale il nostro, / Che non bisogna trattarlo da pensione / In vista d’un albergo più immortale, / Giacché noi siamo fatti l’un per l’altro; // E che infine, e nulla è meno sottile, / Poiché tali gratuite antinomie / In fondo non ci riguardan mica, / L’arte suprema è il Così sia; // E che la parte più bella, fratelli, / E’ vivere di punto in bianco / E magari battendosi il fianco, / Alzar le spalle davanti a ogni cosa” (J. LAFORGUE, Poesie e prose, trad. it. e cura di I. Margoni, Milano, Mondadori, 1971, pp. 179-185).
(30) S. GIVONE, Disincanto del mondo e pensiero tragico, Milano, Il Saggiatore, 1988, p. 22.
(31) V. HUGO, Nostra Signora di Parigi – 1482, trad. it. di V. Valente, prefazione di D. Valeri, Novara, De Agostini, 1964, pp. 53-55 : “Il fortunato papa dei matti fu fatto uscire in trionfo. Ma proprio allora la sorpresa e l’ammirazione raggiunsero il culmine. La smorfia era il suo vero volto. O piuttosto, tutta la sua persona era una smorfia. Una grossa testa irta di capelli di rossi; tra le spalle una gobba enorme, di cui si faceva sentire davanti il contraccolpo; un sistema di cosce e di gambe così stranamente deviate che non potevano toccarsi se non alle ginocchia, e, viste davanti, assomigliavano a due lame adunche di roncola che si riunissero all’impugnatura; piedi enormi, mani mostruose; e, con tutta questa deformità, non so quale spaventoso portamento misto di vigore, di agilità e di coraggio; strana eccezione all’eterna regola che vuole che la forza, come la bellezza, risulti dall’armonia. Tal era il papa che i matti si erano dati. Lo si sarebbe detto un gigante fatto a pezzi e ricucito alla men peggio. Quando questa specie di ciclope apparve sulla soglia della cappella, immobile, tozzo, e largo quasi quanto era alto, quadrato alla base, come disse un grande uomo [Napoleone], la plebaglia, dalla sua sopravveste mezza rossa e mezza viola, cosparsa di campanellini d’argento, e sopra tutto dalla perfezione della sua bruttezza, lo riconobbe immediatamente, ed esclamò all’unisono: “E’ Quasimodo, il campanaro! È Quasimodo, il gobbo di Notre-Dame! Quasimodo il guercio! Quasimodo lo storpio! Evviva! Evviva!”. […] Frattanto, tutti i mendicanti, tutti i lacché, tutti i tagliaborse, unitisi agli scolari, erano andati in processione a cercare, nell’armadio della basoche, la tiara di cartone e la derisoria zimarra del papa dei matti. Quasimodo se ne lasciò rivestire senza batter ciglio e con una sorta di orgogliosa docilità. Poi lo fecero sedere sopra una portantina variopinta. Dodici ufficiali della confraternita dei matti lo sollevarono sulle spalle; e una specie di gioia amara e sdegnosa s’irradiò sulla grama faccia del ciclope, quando vide sotto i suoi piedi deformi tutte quelle teste di uomini belli, diritti e ben fatti. Poi la processione urlante e cenciosa si mise in marcia per fare, secondo l’usanza, il giro interno delle gallerie del Palazzo, prima della passeggiata per le vie e per i crocicchi”.
(32) La dimostrazione condotta al riguardo da F.-W. LUPI nel suo “La scuola dei Sileni”, in Scritti in onore di Eugenio Garin, Pisa, Pubblicazioni della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1987, pp. 1-20, mi sembra al proposito ineccepibile. Sul tema in oggetto, cfr., inoltre, R. BARBOLINI, Il Sileno rovesciato. Socrate nella cultura fin de siècle, Bologna, Cappelli, 1981, che riprende alcuni temi già presenti in C. MALAPARTE, “Commedia dell’ironia” (1925) contenuto in L’Europa vivente e altri saggi politici (1921-1931), a cura di E. Falqui, Firenze, Vallecchi, 1961, pp. 557-585.
Con notevole perspicuità, infatti, Curzio Malaparte scrive a p. 559: “Col rimettere in valore l’essenza del mondo platonico, cioè quella nascosta ma potentissima tendenza all’ironia, di natura scettica e critica, di cui Socrate fu lo sperimentatore e Platone il teorico, la Riforma contribuì in modo sicuro e vigoroso a liberare lo spirito delle giovani nazioni del settentrione da quella felicità di seconda mano, che impediva agli italiani di trarre profitto da certe loro singolari esperienze e di mutare la facezia, la risata e la carnascialata dei novellieri e dei rimatori del secolo d’oro nel sorriso sottilmente scettico, che rivela e accompagna il formarsi dei primi uomini moderni“.
La posizione di Kierkegaard sul Socrate “ironista” è ben riassunta nel brano che segue: “Ma se l’ironia è una determinazione della soggettività, allora deve anche mostrarsi laddove la soggettività fa la sua prima comparsa nella storia universale. L’ironia è appunto la prima e più astratta determinazione della soggettività. Ciò rinvia al punto di svolta storico in cui la soggettività comparve per la prima volta, e così siamo giunti a Socrate. Come fossero andate le cose con l’ironia di Socrate, è già stato chiarito abbastanza nella prima parte di questa indagine. La realtà data tutta aveva perso per lui il suo valore; era diventato estraneo alla realtà intera della sostanzialità. Questo è l’un lato dell’ironia; dall’altro però, nell’annientare il mondo greco si servì dell’ironia; la sua condotta al riguardo fu sempre ironica; era ignorante e non sapeva niente, a di continuo chiedeva lumi agli altri; lasciando però in tal modo sussistere il sussistente, questo andò in rovina. Sviluppò questa tattica all’estremo, e ciò emerse soprattutto quando finì sotto accusa. Ma lo zelo che ci mise lo consumò, e alla fine l’ironia prese lui, gli vengono le vertigini, tutto perde di realtà. Codesta visione di Socrate e del significato storico-universale del suo punto di vista la vedo così rotonda, così naturalmente in se medesima incurvata, che spero proprio si farà strada presso qualche lettore“ (S. A. KIERKEGAARD, Sul concetto di ironia in riferimento costante a Socrate, trad. it. e cura di D. Borso, Milano, Rizzoli, 1995, pp. 266-267).
(33) “Il sipario si apre rapidamente. Ballo. Delle maschere volteggiano seguendo le note silenziose di una danza. Fra loro passeggiano altre maschere, cavalieri, dame, pagliacci. Pierrot siede afflitto in mezzo alla scena, sulla panchina dove di solito si baciano Venere e Tannhäuser. PIERROT. Stavo ritto fra due lampioni / Ed ascoltavo le loro voci: / Bisbigliavano, chiusi nei mantelli, / Li baciava la notte sugli occhi. // E l’argentea bufera intrecciava / Per loro un anello nuziale. / Ed io vidi attraverso la notte / L’amica sorridergli in viso. // Ah, su una slitta che passava / Fece sedere la mia amica! / Trascinandomi nella nebbia di gelo / Da lontano io li seguivo. // Ah, di reti l’aveva avvolta / E ridendo scuoteva il sonaglio! / Ma quando l’ebbe avviluppata, / Ah, l’amica cadde bocconi ! // Nessuna offesa le aveva recato, / Ma nella neve lei era caduta ! / Non poteva tenersi a sedere ! … / Non potei trattenere le risa!… // E sotto la danza degli aghi di gelo, / Intorno alla mia amica di cartone, / Egli suonava ed alto saltava, / Io danzavo intorno alla slitta ! // E cantavamo nella via sonnolenta: / “Ah, che disgrazia è capitata !” / E in alto – sull’amica di cartone – / Risplendeva alta e verde una stella. // E tutta la notte per le vie nevose / Ci trascinammo – Arlecchino e Pierrot… / Così tenero a me s’era stretto, / Solleticava il mio naso la penna ! // Sussurrava: “Siamo insieme, fratello, / E inseparabili, per molti giorni… / Per la fidanzata io e te piangeremo, / Per la tua fidanzata di cartone ! (Si allontana tristemente)”
(A. BLOK, Drammi lirici, trad. it. di S. Leone e S. Pescatori, introduzione di A. M. Ripellino, Torino, Einaudi, 1977, pp. 12-13).
(34) “PRIMO Non ridete. Io non temo né il buon senso, né la volontà, né la fatica, né la rozza forza dell’uomo. Io temo la pazza fantasia, l’assurdità, ciò che un tempo si chiamava sogno sublime. SECONDO Temi la religione, la poesia? Il mondo da tempo le ha superate. Il mondo ha dimenticato i profeti e i poeti. PRIMO Così è stato. Ma nell’ora della morte tutti ricordano il bello che è stato dimenticato. Ella li contagerà con la sua pazzesca bellezza. Invisibile e segreta ella governa adesso la città. Nuova vita vuole infondere nel re” (A. BLOK, Drammi lirici cit. , p. 59).
(35) “PROLOGO. (All’alzarsi del sipario la scena rappresenta l’entrata di una tenda da circo, dalla quale esce un domatore tra suoni di cimbalo e colpi di tamburo. Indossa un frack rosso cinabro, cravatta e pantaloni bianchi, stivaloni con risvolta e porta lunghi riccioli neri. Nella mano sinistra tiene una frusta da cacciatore, nella destra una rivoltella carica). Nobili signori e gaie signore, entrate nel serraglio! Venite ad ammirare con ardente voluttà e gelido orrore la creatura priva di anima domata dal genio dell’uomo. Entrate, lo spettacolo sta per cominciare ! – Ingresso gratuito per ogni bambino accompagnato da due adulti. Nella gabbia angusta si fronteggiano animale e uomo. Quest’ultimo fa schioccare sprezzante la frusta e l’altro, rumoreggiando come il temporale, gli salta al collo con istinti assassini; ora prevale l’astuzia, ora la forza; ora l’uomo, ora la bestia giacciono sconfitti al suolo; l’animale s’impenna, l’uomo è carponi! Ma un gelido sguardo da dominatore fa sì che la bestia, priva di energia, pieghi la nuca e vi lasci umilmente appoggiare sopra il piede. I tempi sono cattivi ! – Tutti i signori e le signore che un tempo si accalcavano davanti alla mia gabbia, oggi onorano della loro pregiatissima presenza le Farse, Ibsen, le Opere e i Drammi. I miei pensionanti non hanno nulla da mangiare e si dilaniano tra loro. […] Ma l’animale autentico, l’animale selvaggio e bello, quello – signore mie ! – lo vedrete soltanto da me. Vedrete la tigre sbranare, com’è suo costume, ciò che le capita al momento sul cammino; vedrete l’orso iniziare voracemente il tardo pasto serale e alla fine di esso cadere a terra morto; vedrete la spassosa scimmietta ormai infiacchitasi per la lunga inazione, dotata di talento, ma priva di grandezza di spirito, civettare con le proprie nudità; sull’anima mia, qui dietro il tendone vedrete perfino un cammello ! – E tutti gli animali mi strisciano docilmente ai piedi, quando (spara un colpo verso il pubblico) la mia rivoltella spara fragorosamente. La belva si aggira intorno fremendo, ma io rimango freddo. – L’uomo rimane freddo! – Per salutare ossequiosamente le Vostre Signorie” (F. WEDEKIND, “Lo spirito della Terra” in Drammi e novelle, trad. it. e cura di L. Gazzerro Righi, Torino, UTET, 1971, pp. 139-140).
(36) Lo ha mostrato R. GENOVESE nella sua Teoria di Lulu. L’immagine femminile e la scena intersoggettiva, Napoli, Liguori, 1983 (ai suoi spunti critici di lettura nei confronti di questo testo aurorale di Wedekind farò più avanti spesso riferimento).
(37) Sul quale cfr. almeno I. A. CHIUSANO, Il teatro tedesco dal Naturalismo all’Espressionismo, Bologna, Cappelli, 1964 e R. PASCAL, Dal naturalismo all’espressionismo. Letteratura e società in Austria e in Germania, 1880-1918, trad. it. di L. Sosio, Milano, Feltrinelli, 19772.
(38) H. MANN, Il professor Unrat – L’Angelo azzurro cit. , p. 271: “Unrat sarebbe stato felice se fosse stato ancora più forte, se non si fosse consegnato in mano alla Fröhlich in un momento di crisi del suo destino, che era quello dell’odio per l’intero genere umano. Lei era l’altra faccia della sua passione: doveva avere tutto, nella stessa misura in cui gli altri perdevano tutto. Era tanto più bisognosa di cure, quanto più gli altri meritavano di essere schiacciati. Su di lei si era riversato tutto lo struggente bisogno di tenerezza provato dall’individuo misantropo E questa era una brutta cosa per Unrat: se lo diceva lui stesso. Si ripeteva che la Fröhlich non avrebbe dovuto essere altro che uno strumento per “pescare” gli allievi e metterli nel sacco. Invece, ormai essa si trovava sullo stesso piano di Unrat, sacra ed eccelsa al cospetto dell’umanità, e lui era costretto ad amarla, e a soffrire per l’amore che le portava, che si rivoltava contro le necessità del suo odio. L’amore di Unrat era votato alla protezione della Fröhlich, e per lei egli si tramutava in predone: era un amore squisitamente maschile. E tuttavia, alla fin fine anche quell’amore gli fiaccava le forze…”. In questo venir meno del Soggetto consiste, in realtà, il Grottesco che definisce la sublimità rovesciata di Un-rat.
(39) Il rovesciamento del Sublime nel Grottesco è cifra stilistica formidabile e costitutivo del procedimento stilistico operato da Céline a partire dal Voyage au bout de la nuit del 1932 giù giù fino alla ricostruzione finale di Rigodon del. 1961. Sul tema del cafarnao céliniano e la dimensione del grottesco che ne deriva, cfr. A. CHESNEAU, Essai de psychocritique de Louis-Férdinand Céline, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1971; M-C. BELLOSTA, Le capharnaüm célinien ou la place des obiects dans Mort à credit, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1976; D. AEBERSOLD, Céline. Un démystificateur mythomane, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1979 e, infine, la ricostruzione filosofico-letteraria di M. GRACCEVA, Le parole e la morte. L’enigma Céline, prefazione di U. Leonzio, Roma, Antonio Pellicani Editore, 1999.
(40) Questo passaggio è evidente in quasi tutti i romanzi di formazione di Malraux a partire da Les Conquérants del 1928 e La Voie Royale del 1930 fino a Les Noyers de l’Altenburg del 1943. Sul tema del Sublime riconfigurato in Malraux quale forma di esaltazione della soggettività che finisce per sprofondare nel grottesco e nella follia, mi permetto di rimandare al mio ”André Malraux lettore di Conrad. Il viaggio, il Sublime, la morte”, in “Parénklesis”, 4, 2006, pp. 127-144. In relazione a questo tema sono inoltre da tenere presenti i libri di S. GAULUPEAU, André Malraux et la mort, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1969; A. LORANT, Orientations étrangères chez André Malraux. Dostoïevski et Trotsky, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1971; E. A. ELLIS, André Malraux et le monde de la nature, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1975; C. MOATTI, La Condition humaine d’André Malraux. Poétique du roman, Paris, Archives des Lettres Modernes-Minard, 1983 e di G. COSTA COLAJANNI, Avventura, storia, miti sociali. Quattro saggi sui “Conquérants” di Malraux, Palermo, Sellerio, 1983.
(41) Ciò è particolarmente evidente nel capolavoro di Drieu La Rochelle, Le Feu follet del 1931. Tale tendenza poi si ritroverà nel successivo Les Chiens de paille del 1944. Buoni spunti sulla sua poetica sono presenti in P. ANDREU, Drieu, témoin et visionnaire, Paris, Grasset, 1952; A. CATTABIANI, Drieu La Rochelle, poeta della decadenza, Presentazione di Pol Vandromme, Torino, Borla, 1965; D. DESANTI, Drieu La Rochelle ou le séducteur mystifié, Paris, Flammarion, 1978 e J. HERVIER, Deux individus contre l’Histoire : Pierre Drieu la Rochelle et Ernst Jünger, Paris, Klincksieck, 1978 .
(42) CFr. J. GENET, Il funambolo e altri scritti, trad. it. e cura di G. Pinotti, Milano, Adelphi, 1997. Sulla parabola di Jean Genet letta sia dal Sartre di Santo Genet, commediante e martire (trad. it. di C. Pavolini, a cura di P. A. Rovatti, Milano, Il Saggiatore, 1972 ) che dal Derrida di Glas (Paris, Galilée, 1974), rimando al mio “Libertà come scarto tra essere e non essere. Note su Saint Genet, comédien et martyr di J.-P. Sartre”, in “Riscontri”, (III), 1, gennaio-marzo 1981, pp. 37-54.
(43) R. GENOVESE, Teoria di Lulu. L’immagine femminile e la scena intersoggettiva cit. , p. 36.
(44) R. GENOVESE, Teoria di Lulu. L’immagine femminile e la scena intersoggettiva cit. , pp. 36-37.
(45) “Cantico dell’uomo Baal (1919). “ 1. Quando crebbe nel materno bianco ventre Baal / già era il cielo così grande e quieto e scialbo / giovane e nudo e immensamente strano / come piacque allora a Baal, quando Baal nacque. // 2. E restava in gioia o pena là quel cielo / anche se non lo vedeva, beato in sonno, Baal: / viola a notte se Baal ubriaco; / se, all’alba, mite Baal, come albicocca scialbo. // 3. Degli empi nel groviglio di vergogna / giacque ignudo e si torse in pace Baal. / Solo il cielo, ma celava il cielo / possente, sempre, la sua nudità. // 4. Tutti i vizi a qualche cosa servono, / e anche l’uomo, Baal diceva, che li pratica. / Son qualcosa i vizi, se si sa quel che si vuole. / Due sceglietevene: ché è troppo, uno. // 5. Così pigri no, non subito stanchi: ché godere, perdio, non è facile ! / Membra robuste ci vogliono, esperte anche: / mentre guasta, troppo grasso, un ventre. // 6. Fissa gli avvoltoi gonfi lassù Baal, / che il cadavere Baal dai cieli aspettano. / Qualche volta Baal fa il morto. Uno giù / piomba e Baal a cena, zitto, un avvoltoio si mastica. // 7. Sono astri sinistri nella vale di pianto / ruminando Baal vasti campi pascola. / Quando sono spogli, trotta Baal e canta / per la selva eterna verso il sonno. // 8. E quando il ventre buio Baal giù trae, / che è il mondo ancora per Baal? Sazio è Baal. / Tanti cieli Baal sotto le ciglia porta / che ha cielo da bastargli anche da morto. // 9. Quando dentro il ventre buio della terra Baal marcì / era ancora il cielo grande e quieto e scialbo / giovane e nudo e immensamente splendido / come piacque allora a Baal, quando Baal fu“ (B. BRECHT, Poesie e canzoni, trad. it. di R. Leiser e F. Fortini, a cura di F. Fortini, Torino, Einaudi, 1971 [7 ed.], pp. 4-5).
(46) “Il poeta sentimentale illumina il pubblico: lo spettatore non solo può rivivere l’ingiustizia del mondo, provando compassione o terrore, ma riconoscerla anche come effetto di determinate cause; non ve solo assistere, commosso e sbigottito, ai furori di un Karl Moor, di un Fernando, ma anche approvarli, contribuirvi con la propria rabbia. Lo scoglio che fa naufragare l’uomo è la snaturatezza del mondo. Il figlio insorge contro il padre, il fratello si rivolge contro il fratello. L’uomo perisce senza colpa. Il suo sacrificio non ha che un senso interiorizzato. Esso mette a nudo la tragicità della libertà, oppure denuncia un ordine sociale ingiusto; in un senso esteriore, però, il suo sacrificio è vano, poiché non porta all’ordine sociale giusto. A questo punto è lecito chiedersi se questo atteggiamento sia sufficiente, o se la coscienza dello stato malsano del mondo non debba invece fondarsi sulla coscienza di come dovrebb’essere, comportando con ciò stesso l’imperativo morale di indicare la via per ristabilire il giusto ordine, e di esortare a seguirla. Se è così, non basta più mostrare un mondo ingiusto. Occorre mostrare un mondo trasformabile, un mondo che può essere ricondotto al suo ordine e nel quale l’uomo non sia più vittima. In questo caso però lo scrittore, da ribelle, diventa rivoluzionario. Ma con ciò il mio discorso prende una piega preoccupante, poiché lascia il campo prettamente drammaturgico, dove si può discorrere di questioni del mestiere senza rischio di pericoli, per inoltrarsi in regioni più accidentate. Schiller è un tema fin troppo scomodo e, purtroppo, un caso squisitamente politico. Non sarà sfuggito a nessuno che la mia interpretazione del teatro ingenuo e sentimentale ha mancato, in apparenza, il bersaglio Schiller centrando invece in pieno Brecht, il quale, in realtà, rivela all’occhio attento molte affinità con Schiller, anche in certi tratti amabili, come la tendenza a involontari effetti comici. […] Questo grande scrittore rappresenta la forma estrema del poeta sentimentale. Egli ha superato lo stadio della ribellione, per diventare rivoluzionario, per trasformare la società attraverso il suo teatro. Lo sappiamo, è diventato comunista. Qui va detta una cosa, però, anche se è ovvia ci sarà chi si duole dell’ideologia di Brecht, altri ne saranno irritati; ma non si può trattarla come mero smarrimento, fattore secondario. Essa arte integrante di Brecht, una qualità delle sue opere che non è dovuta al caso, come non lo sono l’efficacia teatrale, la precisione poetica, l’audacia drammaturgia e, non ultimo, la loro umanità. La validità del suo lavoro impone una valutazione obiettiva del suo comunismo. Non è il caso di ricorrere a sotterfugi; dobbiamo riconoscere quel che va riconosciuto. L’opera poetica di Brecht è una risposta al nostro mondo, alla nostra colpa; una delle poche risposte oneste, ancorché comunista, alle nostre frasi vuote, un’esposizione di ciò che abbiamo trascurato di fare. Non possiamo ignorare Brecht“ (F. DÜRRENMATT, Lo scrittore nel tempo. Scritti su letteratura, teatro e cinema, trad. it.di B. Baumbusch e G. Ciabatti,, Torino, Einaudi, 1982, pp. 88-89).
(47) Si tratta di quelli che sono meglio conosciuti come “21 punti su I fisici ”. Cfr. F. DÜRRENMATT, I fisici, trad. it. e cura di A. Rendi, Torino, Einaudi, 1972 [3 ed], pp. 83-84: “1. Io non parto da una tesi, bensì da una storia. 2. Se si parte da una storia, bisogna pensarla fino alla sua estrema conclusione. 3. Una storia è pensata fino alla sua estrema conclusione quando ha preso il peggiore sviluppo possibile. 4. Il peggiore sviluppo possibile non si può prevedere. Avviene per caso. 5. L’arte dell’autore drammatico consiste nel far intervenire il caso nell’azione in maniera quanto più efficace possibile. 6. L’azione drammatica si basa sugli esseri umani. 7. Nell’azione drammatica il caso consiste in chi incontra per caso chi e dove e quando. 8. Quanto più sistematicamente agiscono gli uomini, tanto più efficacemente può il caso colpirli. 9. Gli uomini che agiscono sistematicamente vogliono raggiungere un determinato obiettivo. Il caso li colpisce nel modo più grave, quando raggiungono grazie ad esso il contrario del loro obiettivo e cioè quel che temono e cercano d’evitare (per esempio: Edipo). 10. Una tale storia è grottesca, ma non assurda (contraria al senso comune). 11. Essa è paradossale. 12. Gli autori drammatici, come i logici, non possono evitare il paradosso. 13. I fisici, come i logici non possono evitare il paradosso. 14. Un dramma che tratti di fisici deve essere paradossale. 15. Non può avere per obiettivo il contenuto della fisica, ma solo i suoi effetti. 16. Il contenuto della fisica riguarda solo i fisici, i suoi effetti riguardano tutti. 17. Ciò che riguarda tutti può essere risolto soltanto da tutti. 18. Ogni tentativo del singolo di risolvere per conto suo ciò che riguarda tutti è destinato a fallire. 19. Nel paradosso si rivela la realtà. 20. Chi si trova di fronte al paradosso si espone alla realtà. 21. L’opera drammatica può indurre lo spettatore a esporsi alla realtà, ma non può costringerlo ad affrontarla o addirittura a risolverla”. Nonostante il punto di partenza (il paradosso della realtà come espressione drammaturgica) siamo lontani anni luce dallo straniamento “salvifico” di marca brechtiana.
Su questi temi, che sono estetici e politici insieme, mi permetto di rimandare al mio libro Lo scrittore nel tempo. Friedrich Dürrenmatt e la poetica della responsabilità umana, Chieti, Solfanelli, 2005.
(48) A questo proposito, cfr. E. PISCATOR, Il teatro politico, trad. it. di A. Spaini, introduzione di M. Castri, Torino, Einaudi, 19762.
(49) “Si prenda la scena di Le Due Orfanelle (1921) in cui Lillian Gish ode la voce lontana della sorella da tempo perduta, che chiede l’elemosina nella strada sottostante. Griffith mantiene sempre in primo piano il volto etereo di Lillian Gish; i capelli biondi della protagonista sono illuminati da un alone di luce. […] La Gish esita, scuote la testa: “ No “ e si vede quasi che abbandona la speranza. “ Non può essere mia sorella”. Ma la voce le arriva ancora agli orecchi. I suoi occhi brillano di speranza, poi il brillio scompare quando essa attribuisce il suono della voce alla propria immaginazione. Quando si ode nuovamente la voce, i suoi occhi si riempiono di lacrime, e anche i nostri. Si raggiunge il momento culminante della scena condividendo con Lillian Gish un senso di amore e disperazione instillato da una regia magistrale” (K. BROWNLOW, Hollywood. L’era del muto, trad. it. di M. G. Pizzoni, Milano, Garzanti, 1980, p. 102).
Brownlow è il celebre restauratore dell’edizione completa del film Napoléon (1927) di Abel Gance.
(50) Cfr. V. GENTILI, La recita della follia. Funzioni dell’insania nel teatro dell’età di Shakespeare, Torino, Einaudi, 1978, pp. 52-53: “In realtà, il fool fa, in teatro, da contrasto al re o al padrone, così come nella prassi delle corti e delle case nobiliari ne è membro indispensabile del seguito; e i suoi discorsi livellatori non tanto sono dissacranti quanto piuttosto ribadiscono il motivo cristiano-medievale dell’uguaglianza fra deboli e potenti di fronte alla vanità delle cose terrene e alla malvagità degli uomini (e in ultima analisi di fronte alla morte, che un re shakesperiano personifica, appunto, in un “buffone” che “schernisce la maestà e irride alle sue pompe”, Richard II, atto III, scena II, pp. 162-163), senza, peraltro, darci quel corrosivo senso del creaturale che troviamo nelle riflessioni di un Montaigne. Sono semmai discorsi che, nell’accomunare condizioni difformi, toccano la soglia dell’”alienazione nell’analogia”, per dirla con Michel Foucault dal qual ci sembra si possa mutuare la definizione del personaggio del pazzo nella letteratura barocca per applicarla, naturalmente, al fool…” .La Gentili si appoggia per la sua tesi (almeno in parte) a J. KOTT, Shakespeare nostro contemporaneo, trad. it. di V. Petrelli, prefazione di M. Praz, Milano, Feltrinelli, 1964., un testo che è ormai diventato un classico della letteratura teatrale e poi a Le parole e le cose di Michel Foucault (un altro libro ormai divenuto anch’esso un classico della storia filosofica dei concetti storici).
(51) Cfr. E. AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, trad it. di A. Romagnoli e H. Hinterhäuser, con un saggio introduttivo di A. Roncaglia, Torino, Einaudi, 1956 sgg.
(52) Su di essa, oltre naturalmente alla lettura diretta della Poetica, cfr. G. CARCHIA, Orfismo e tragedia. Il mito trasfigurato, Milano, Celuc, 1979. Sull’argomento, inoltre, mi permetto di rimandare al mio “Il Tragico e il Sublime in letteratura” in Aura. Scritti per Gianni Carchia, a cura di L. Lanzardo, Torino, Edizioni SEB27, 2002, pp. 184-194
(53) Cfr. W. BURKERT, Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica, trad. it. di F. Bertolini, Torino, Bollati Boringhieri, 1981 (si tratta di un testo fondamentale su questo problema affrontato fin dai tempi di Giambattista Vico e mai risolto). Dello stesso autore, assai interessante è anche il successivo Origini selvagge. Sacrificio e mito nella Grecia arcaica, con un saggio di G. Most, trad. it. di M. R. Falivene, Roma-Bari, Laterza, 1992.
(54) Cfr. R. GIRARD, La violenza e il sacro, trad. it. di O. Fatica e E. Czerkl, Milano, Adelphi, 1980. Sul tema caro a Girard della connessione tra pratica introiettata della violenza ed epifania del sacro, cfr. S. TOMELLERI, René Girard. La matrice sociale della violenza, Milano, Franco Angeli, 1997. Molto importante ai fini della comprensione del progetto ermeneutico di Girard è anche l’antologia La vittima e la folla nei miti del cristianesimo, testi scelti e tradotti a cura di G. Fornari, Treviso, Santi Quaranta, 1998.
(55) La citazione si trova in J. STAROBINSKI, Portrait de l’artiste en saltimbanque cit. , p. 22.
(56) Ben lo sapeva anche Céline, non a caso autore di una straordinaria partitura musicale in prosa intitolata Féerie pour une autre fois del 1952 (romanzo che avrà nel 1954 un suo seguito naturale intitolato Normance: Féerie pour une autre fois II).
(57) “ I. Sempre, così, verso il ceruleo nero / Ove trepida il mare dei topazi, / Funzioneranno dentro alla tua sera / I Gigli, clisteri d’estasi! // Ai nostri tempi di sagù, / In cui le Piante sono laboriose, / Il Giglio si berrà i disgusti azzurri / Nelle tue Prose religiose! //– Il giglio del signore di Kerdrel, / Il Sonetto milleottocentotrenta, / Il Giglio donato al Menestrello / Col garofano e con l’amaranto! // Gigli! Gigli! Non se ne vedono ! / Ma nel tuo verso, come le maniche / Di Peccatrici dal molle passo, / Fremono sempre questi fiori bianchi! // Sempre, Caro, quando fai un bagno, / La tua camicia dalle ascelle bionde / Si gonfia alla brezza mattutina / Sui myosotis immondi! // L’amore al tuo dazio lascia passare / Soltanto Lillà, –oh le biciàncole! / E le violette dei Boschi, / Dolci scaracchi delle Ninfe nere!… // II. Oh Poeti, se anche aveste / Le rose, le rose soffiate, / Rosse su steli di lauro, / Da mille ottave gonfiate! // Se BANVILLE ne facesse nevicare, / Sanguinolente, vorticosamente, / Pestando l’occhio folle dell’ignaro / Con letture male amorevoli ! // Dalle vostre foreste e da quei prati, / Oh ben pacifici fotografi ! / La Flora è diversa suppergiù / Come dai tappi di bottiglia ! // […] V. Qualcuno dirà il grande Amore, / Ladro di oscure Indulgenze: / Ma né Renan, né il gatto Murr / Videro gli Azzurri Tirsi immensi ! // Tu, fa’ che nei torpori i profumi / Ridestino le nostre isterie, / Esaltaci verso candori / Più candidi delle Marie… // Commerciante ! medium ! colono! / La Rima sgorgherà, rosea o bianca, / Come un raggio di sodio, / Come un caucciù che si espanda! // Dai tuoi neri Poemi, – Funambolo ! / Bianchi, verdi, diòttrici rossi, / Sgùsciano via strani fiori / E farfalloni elettrici! // Ecco ! E’ il Secolo d’inferno ! / I pali del telegrafo orneranno / – Lira dai canti di ferro, / Le tue superbe scapole! // Soprattutto, rimaci una versione / Sulla malattia delle patate! / – E, per la composizione / Di Poemi colmi di mistero / Leggibili da Tréguier / A Paramaribò, da te siano acquistati / I Tomi del signor Figuier, / – Al’Editore Hachette ! – ma illustrati! Alcide Bava” (A. RIMBAUD, “Quel che si dice al poeta a proposito di fiori” in Opere, trad. it. e cura di D. Grange Fiori, Introduzione di Yves Bonnefoy, Milano, Mondadori, 1975, pp. 119- 129)
(58) Su questo tema (che è poi il titolo originale del libro citato), cfr. M. BERMAN, L’esperienza della modernità, trad. it. di V. Lalli, con un’introduzione di E. Battisti, Bologna, Il Mulino, 1985.
(59) Quella folla, invece, il cui contatto ricerca disperatamente “l’uomo della folla” dell’omonimo, ben noto racconto di Edgar Allan Poe (cfr. E. A. POE, “L’uomo della folla”, trad. it. di E. Vittorini, in Opere, a cura d G. Manganelli, Milano, Mondadori, 1971, pp. 396-406).
(60) Scrive, ad esempio, Piranesi nel suo Parere su l’Architettura. Dialogo tra Protopino e Didascalo che è del 1765: “Il mio giudizio, quanto agli ornamenti, eccolo. Ditemi, per qual diversità, allora quando immaginiamo una cosa, ella ci parrà bella; e quando la mettiamo in opera, ci dispiace? Perché niuno si è mai avvisato di condannar ne’ poeti quegli edifizj ch’egli hanno immaginato ed arricchito con ornamenti tanto più irragionevoli e strani di quei che si usano dagli Architetti? Il Montesquieu biasima un edifizio carico d’ornamenti; ma intanto non dice, che sia confuso un poema in quella parte ove ci descrive così fatti edifizj. Appuriamo donde ciò venga. Vien ciò forse da che l’idea non ci fa vedere ciò che ci scuopre l’occhio? Io così credo: il poeta da un ornamento ci conduce all’osservazione dell’altro, e ci lascia là, senza mostrarcene, o rendercene sensibile la riunione: piacciono per esempio nel poeta questi e quegli ornamenti, come ti lodano, veduti in tante statue d’un bravo artefice i piedi d’un Cupido, le gambe d’un Adone, il viso d’una Venere, le braccia d’un Apollo, il petto d’un Ercole, il naso d’un gigante ecc. Ma accattate un po’ da queste diverse statue, stature, e naturalezze, sì fatte parti, e ponetele insieme; che ne risulterà? Una statua ridicola, un mostro che vi ributta. Difetti simili a questi, son quelli ch’io non approvo nell’Architettura. Si vegno quasi per tutto parti in se stesse pregevoli, ma insoffribili quando elle sono accozzate insieme; perché ne presentano il molto pregiudicato dal poco, il grave dal leggieri, il maestoso dal piccolo e dal meschino. Or, affinché tante parti, trovate belle in se stesse, si reggano e durino ad esser tali quando sono insieme, né il compiacercene ci sia defraudato dalla incompatibilità, ponghiamo del grave e del maestoso in ciò che ne apparisce meschino” (G. B. PIRANESI, Scritti di storia e teoria dell’arte, a cura di P. Panza, Varese, SugarCo Edizioni, 19942, p. 262).
Per un’analisi più dettagliata del percorso architettonico e grafico di Giovan Battista Piranesi vedi più oltre.
Per una ricostruzione della sua fortuna in epoca illuministica, cfr. il mio “Visioni dell’Orrore. Sade, Potocki, von Kleist” in Il Sublime e la prosa. Nove proposte di analisi letteraria cit. , pp. 59-90.
Sul mito costituito dalla vita e dalle opere del grande incisore di Mojano di Mestre e sul fascino esercitato dalle raffigurazioni piranesiane in età romantica, cfr. L. KELLER, Piranèse et les romantiques françaises, Paris, José Corti, 1966 ed il saggio di A. REED; “Abysmal Influence: Baudelaire, Coleridge, De Quincey, Piranesi, Wordsworth”, in “Glyph”, 4, 1978, pp. 189-206.
(61) J. STAROBINSKI, Portrait de l’artiste en saltimbanque cit. , p. 60.
(62) Su questo aspetto della Natura in relazione al Sublime, cfr. F.-W. LUPI, Derive del Sublime, in F.-W. LUPI – G. PANELLA, Del Sublime, Frosinone, DismisuraTesti, 1994, pp. 13-44.
(63) Come scrive T. W.-ADORNO nel suo aforisma che reca questo titolo (e che è contenuto in Minima moralia. Riflessioni sulla vita offesa, trad. it. e cura di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1974 (2 ed)2, pp. 165-166): “L’inutile beauté. Donne di singolare bellezza sono condannate alla sventura. Anche quelle che hanno tutte le condizioni favorevoli, e che sono assistite dalla nascita, dalla ricchezza, dal talento, sembrano come perseguitate o possedute dall’impulso alla distruzione di sé e di tutti i rapporti umani a cui partecipano. Un oracolo le costringe alla scelta tra destini ugualmente fatali. O scambiano saggiamente la bellezza col successo, e pagano con la felicità la condizione di questo: non essendo più in grado di amare, avvelenano l’amore che gli altri nutrono per loro e finiscono per restare a mani vuote. Oppure il privilegio della bellezza conferisce loro il coraggio e la sicurezza di rinunciare allo scambio. Prendono sul serio la felicità che in esse si promette, e non sono avare di sé, poiché l’inclinazione di tutti consente loro di non rappresentarsi direttamente il proprio valore. La scelta cade nella loro giovinezza, e ciò le mette nell’impossibilità di scegliere: nulla è definitivo, tutto è subito sostituibile. Molto presto, senza rifletterci troppo, si sposano, si obbligano a doveri pedestri, e si privano, in un certo senso, del privilegio della possibilità infinita: si abbassano, cioè, a comuni mortali. Ma nello stesso tempo restano attaccate al sogno infantile di onnipotenza che la vita fece balenare davanti a loro, e non cessano – in questo non borghesi – di rinunciare all’uovo di oggi per la gallina di domani. E’, il loro, un tipo particolare di carattere distruttivo. Proprio il fatto di essere state un tempo fuori concorso, le mette in coda alla concorrenza, che ora esercitano con furia morbosa. Il gesto dell’irresistibilità sopravvive all’irresistibilità perduta: il fascino decade, non appena, anziché rappresentare una speranza, fissa, per così dire, il proprio domicilio. Ma quella che non è più irresistibile è subito vittima: è sottomessa all’ordine che un tempo sorvolava. La sua generosità riceve il giusto castigo. L’appassita come l’ossessa sono martiri della felicità. La bellezza inquadrata nell’ordine si è trasformata in un elemento calcolabile dell’esistenza, in un surrogato della vita che non esiste, senza trascendere in nulla questa funzione. Essa non ha mantenuto la sua promessa di felicità per sé e per gli altri. Ma quella che insiste assume l’alone della sventura, ed è colpita a sua volta dalla sventura. Il mondo razionalizzato ha assorbito e liquidato definitivamente il mito. L’invidia degli dei sopravvive agli dei ”.
(64) Una traduzione italiana possibile è “un borgo (o un casale) quieto”.
(65) G. ALMANSI, L’estetica dell’osceno (con un’ Appendice 1980), Torino, Einaudi, 1980 (2 ed), p. 188.
(66) Con intuizione geniale, Jean-Paul Sartre annota a questo proposito: “ Checché ne sia, quella grande forma frigida, muta ed immobile, è per lui come la sanzione sociale erotizzata; come quegli specchi dai quali certi raffinati si fan rimandare l’immagine dei loro piaceri: gli consente di vedersi mentre fa all’amore. Ma, più direttamente ancora, è colpevole di amarla dacché lei non lo ama. Più colpevole ancora se la desidera e la insozza. Ella personifica, con la sua stessa frigidezza, il proibito. E se gli giura e spergiura di rispettarla, è perché i suoi desideri siano delitti più grandi. Ecco di nuovo la colpa e il sacrilegio: la donna è lì, attraversa la stanza con quell’andatura indolente e maestosa che Baudelaire ama e che basta da sola a significare l’indifferenza e la libertà. Ella nota Baudelaire o press’a poco: se per caso lo guarda, è qualunque agli occhi suoi; egli passa traverso i suoi sguardi. Comme passe le verre au travers du soleil.
Muto, seduto lontano da lei, si sente insignificante e trasparente: un oggetto. Ma nel momento stesso in cui gli occhi della bella creatura gli assegnano un posto nel mondo che lo sguardo di lei pone in ordine senza passione, egli sfugge, la desidera, affonda nel peccato. E’ colpevole, è indifferente. Le due “postulazioni simultanee” gli riempiono l’anima di un sol tratto: è invaso dalla duplice presenza di quegli inseparabili: il Bene e il Male. In pari tempo, la frigidità della donna amata spiritualizza i desideri di Baudelaire e li trasforma in “voluttà” “ (J. -P. SARTRE, Baudelaire, trad. it. di J. Darca, Milano, Il Saggiatore, 1965 (4 ed), pp. 111-112). Di interesse straordinario per la comprensione del personaggio-Baudelaire è il racconto Venere nera dedicato da Angela Carter al poeta parigino (A. CARTER, Venere nera, trad. it. di B. Lanati, Milano, Feltrinelli, 1987).
(67) Come scrive Georges Bataille: “Sembra che si possa cogliere il Male, ma solo nella misura in cui il Bene può esserne la chiave. Se l’intensità luminosa del Bene non concedesse la sua tenebra alla notte del Male, il Male non avrebbe più la sua attrattiva. È una verità difficile: colui che la intende sente rivoltarsi qualcosa in sé. Sappiamo tuttavia che gli oltraggi più forti alla sensibilità provengono da contrasti […] La felicità senza la sventura che si lega ad essa come l’ombra alla luce sarebbe oggetto di una immediata indifferenza. Questo è tanto vero, che i romanzi descrivono senza posa la sofferenza e quasi mai la soddisfazione. Insomma, il pregio della felicità consiste nel non essere frequente: se fosse facile, verrebbe sdegnata, e associata alla noia […] la verità non sarebbe quella che è, se non si ponesse generosamente contro il falso” (G. BATAILLE, La letteratura e il male, trad. it. di A. Zanzotto, Milano, SE, 1997 (2 ed), pp. 129-131).
(68) Scrive sempre Sartre: “Così è Baudelaire: quando sente crescere in lui la natura, la natura di tutti, come un’inondazione, si ritrae e s’irrigidisce, tiene la testa fuor dell’acqua. Quel gran flutto fangoso è la volgarità in persona: Baudelaire si irrita di sentire in se stesso quelle onde vischiose che così poco assomigliano ai sottili artifizi di cui sogna; soprattutto si irrita di sentire che quella forza irresistibile e dolciastra vuol forzarlo a “fare come tutti”. Perché la natura dentro di noi è l’opposto del raro e dello squisito, è tutti. Mangiare come tutti, dormire come tutti, fare all’amore come tutti: quale insania! Ognuno di noi sceglie in se stesso, tra le proprie componenti, quelle di cui dirà: sono io. Le altre le ignora. Baudelaire ha scelto di non esser natura, di essere il perpetuo e astratto diniego della propria indole naturale, la testa che si drizza fuor dall’acqua e che guarda crescere i flutti con un misto di sprezzo e di terrore. La selezione arbitraria e libera che operiamo in noi stessi costituisce in linea di massima quel che si chiama il nostro “stile di vita”. Se acconsentite al vostro corpo e vi ci lasciate andare, se vi piace tuffarvi nella lieta fatica, i bisogni, il sudore e tutto ciò che vi fa uguali agli altri uomini, se avete un umanesimo della natura, i vostri gesti avranno una specie di schiettezza e di generosità, una sciolta disinvolta. Baudelaire detesta il lasciarsi andare. Non ha, dalla mattina alla sera, un attimo di abbandono. I suoi minimi desideri,i suoi slanci più spontanei sono controllati, filtrati, recitati più che vissuti; non han via libera se non quando siano debitamente resi artificiali. Di qui, in parte, quel culto della toletta e dell’abbigliamento che debbono mascherare la nudità troppo naturale, di qui quelle fantasie che sfiorano talvolta il ridicolo. Come il tingersi i capelli di verde. In lui neppure l’ispirazione trova grazia” (J.- P. SARTRE, Baudelaire cit. , pp. 97-98).
(69) Cfr. J.-P. SARTRE, Baudelaire cit., pp. 131-132 : “Per chi sa leggere tra le righe, è chiaro che il dandysmo rappresenta un ideale più elevato della poesia. Si tratta di una società al quadrato, sul modello della comunità di artisti ideata da Flaubert, da Gautier e dai teorici dell’Arte per l’Arte. Da tal modello prende in prestito le idee di gratuità, di solidarietà meccanica e di parassitismo, ma è assai più severo quanto alle condizioni di ammissione. Le caratteristiche essenziali dell’artista vengono esagerate, spinte al limite. L’esercizio ancor troppo utilitario del mestiere artistico diventa il puro cerimoniale della toletta; il culto del bello che produce opere stabili e durature si cambia in amore dell’eleganza, perché l’eleganza è effimera, sterile e peritura; l’atto creativo del pittore o del poeta, svuotato della sua sostanza, prende forma di atto strettamente gratuito, nel senso gidiano, e persino assurdo; l’invenzione estetica si trasforma in mistificazione; la passione di creare si congela in insensibilità. […] non vuol saperne d’una società che duri quanto la specie umana. Affinché essa abbia un’impronta di rarità e di unicità, bisogna che sia, nel seno stesso dell’umanità, votata a scomparire. Ecco perché il dandysmo sarà “l’ultimo bagliore d’eroismo nelle decadenze… un sole al tramonto”. In una parola, aldilà della società aristocratica ma “secolare” degli artisti, Baudelaire istituisce un ordine regolare che rappresenta la spiritualità pura; e quanto a lui pretende di appartenere alle due comunità contemporaneamente, la seconda non essendo d’altronde che la quintessenza della prima. Così questo solitario che teme la solitudine ha risolto il problema dei rapporti sociali con l’immaginare delle relazioni magiche di partecipazione tra isolati, la maggior parte dei quali sono morti; ha creato il parassita dei parassiti: il “dandy” parassita del poeta, che è a sua volta parassita d’una classe di oppressori; aldilà dell’artista, che cerca ancora di creare, ha progettato un ideale sociale di sterilità assoluta dove il culto dell’io s’identifica con la soppressione di se stessi“.
Sul tema del dandy in rapporto alla poesia francese dell’Ottocento, mi permetto di rimandare ai miei saggi “Eroi. Paragrafi per un’antropologia prammatica del Moderno”, in ”Figure”, (3), 8, 1984, pp. 81-93 e “Subjektive Schauplätze. Ritratto del dandy come poeta”, in “Riscontri”, (V), 1, gennaio-marzo 1983, pp. 53-78.
(70) C. BAUDELAIRE, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Milano, Mondadori, 1975, p. 604.
(71) C. BAUDELAIRE, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose cit., p. 607.
(72) C. BAUDELAIRE, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose cit., ibidem. Valéry eredita questo tema da Baudelaire e lo fonde con la sua ammirazione plastica per Edgar Degas. Per meglio comprenderne la potenzialità e gli sviluppi, cfr. P. VALÉRY, Degas danza disegno, trad. it. e cura di B. Dal Fabbro, Milano, Feltrinelli, 1980 e il bel saggio di .S. GIVONE, “Il destino dell’arte secondo Paul Valéry”, in Hybris e Melancholia. Studi sulle poetiche del Novecento, Milano, Mursia, 1974, p. 24.
(73) C. BAUDELAIRE, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose cit, pp. 610-611.
(74) Su questo tema, centrale per l’arte contemporanea, cfr. U. VOLLI, Fascino. Feticismo e altre idolatrie, Milano, Feltrinelli, 1997. Sul tema del feticismo in filosofia e psicoanalisi, cfr. il volume collettivo Marx, Freud, Lacan: le basi materialistiche nella psichiatria e nella psicoanalisi, a cura di A. Guidi, introduzione di A. Masullo, Roma, Borla, 1999 (il libro contiene anche una mia appendice sulla storia del concetto filosofico di feticismo dal Presidente de Brosses a Marx e Lacan passando attraverso le ipotesi di Kant e Comte).
(75) C. BAUDELAIRE, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose cit., pp. 611-612.
(76) C. BAUDELAIRE, “La Fanfarlo”, in Poesie e prose cit., pp. 614-615.
______________________________
Scarica il saggio RIFRAZIONI DEL SUBLIME. DALL’ ORRORE AL GROTTESCO in formato PDF ]
______________________________
[QUI] puoi scaricare i saggi di letteratura in formato PDF pubblicati da Retroguardia 2.0.
______________________________
[Leggi tutti gli articoli di Giuseppe Panella pubblicati su Retroguardia 2.0]