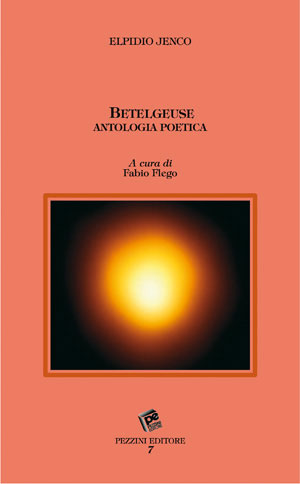 Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)
Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)
di Giuseppe Panella
Alla ricerca dei poeti dimenticati. Elpidio Jenco, Betelgeuse. Antologia poetica, a cura di Fabio Flego, con uno scritto raro di Ettore Serra e un ricordo di Giovanni Pieraccini, Viareggio (LU), Pezzini Editore, 2009
Elpidio Jenco appartiene oggi interamente alla condizione dei poeti dimenticati (non sempre deliberatamente, spesso solo malauguratamente o casualmente, per uno di quei giochi del destino che non sono soltanto il frutto della malignità degli uomini ma solo aspetti della condotta del mondo). Per questo motivo, riproporlo come autore in un’antologia ampia, ben impostata e ben coordinata come questa realizzata da Fabio Flego è merito non da poco.
Il fatto è che Jenco è stato facilmente confuso con i poeti della sua generazione e archiviato con una certa faciloneria come uno qualunque di essi (sic et simpliciter). Come scrive Flego nella sua Premessa al volume, il poeta di Caserta trapiantato a Viareggio è stato rapidamente assimilato agli altri scrittori di versi presenti negli stessi luoghi e nella stessa temperie in cui egli ha vissuto:
«All’ombra di un platano sul lato nord della piazza di Forte dei Marmi – il Quarto Platano, appunto, del caffè Roma –, una foto degli anni quaranta ritrae il cenacolo di scrittori e di pittori che fin dal dopoguerra, d’estate, all’imbrunire, là si riunivano attorno alla figura patriarcale di Enrico Pea, avvolto nella sua candida barba. In quell’”officina versiliese” del dibattito artistico-letterario, che oggi solo un’elegante epigrafe dettata da Piero Bigongiari ricorda, tra i Rapaci, i Carrà, De Grada, Montale e Pea, accanto ad Angioletti, siede anche, in maniche di camicia, Elpidio Jenco. […] Francesco Flora, sicuro della rispondenza della vita all’arte in Elpidio Jenc, non esita ad inserirlo nella sfera dei poeti “benedetti” ed a sottolinearne la “vena tenue, limpidamente modulata, sagacemente armonizzata nelle sue sintesi analogiche”:“discreta com’era l’uomo, incantevole figura, la cui presenza spesso silenziosa, appena schiusa a qualche sorriso e al palpito vivo dello sguardo, irradiava un’umanissima compagnia, destava e chiedeva una rispondenza d’amicizia”» (1).
Jenco appartiene, dunque, a quel cenacolo di poeti versiliesi che si radunavano tutte le estati sotto i platani della passeggiata a mare di Viareggio e che caratterizzavano con la loro presenza la vita culturale della cittadina balneare. Ma questo, ovviamente, non basterebbe a definire la figura lirica del poeta stesso né sarebbe sufficiente a dare una valutazione di merito della qualità della sua scrittura. In realtà alla conoscenza compiuta della sua biografia culturale mancano troppi elementi se lo si riduce a quella dell’autore di versi stagionali e di precursore in epoca non sospetta della tradizione ermetica.
L’elemento di discrimine nella non abbondantissima (ma sicuramente rilevante) produzione di Jenco è data dal suo amore per la lirica orientale e per le sue forme compositive, una passione questa che lo spinse a fondare nel 1920, con alcuni amici e sodali e soprattutto insieme a Harukichi Shimoi, allora titolare dell’insegnamento di giapponese presso l’Istituto Orientale di Napoli, la rivista Sakurà. Essa ebbe vita breve (cessò le pubblicazioni nel marzo del 1921) ma rappresentò una pietra miliare nel panorama culturale italiano che guardava all’Oriente in maniera né approssimativa né provinciale e, soprattutto, non folcloristico.
L’amore per le forme tradizionali della scrittura poetica giapponese e, in particolare per gli haiku e i tanka, ispireranno poi tutta la produzione di Jenco e renderanno asciutta e liricamente librata e libera una scrittura che altrimenti poteva rischiare, satura dell’ambiente culturale dell’epoca, l’abbraccio mortale con il tardo carduccianesimo o la reboante carica d’urto del dannunzianesimo trionfante. Ad essi il progetto di depurazione della pagina poetica che caratterizzò sempre la proposta lirica di Jenco non si accostò mai e le brevi toccanti linee dei suoi lavori più mature mostrano bene il segno di una ricerca di liberazione dalla materialità del tratto e del segno in nome della spiritualità della prospettiva e del tocco lirico.
Quello che il poeta chiede alla sua scrittura poetica è, quindi, di liberarlo dalla materia. Come scrive in uno dei suoi testi più forti in questo senso:
«UOMO. Io lo so che sorte ti mena, / uomo effimero grumo di pena. / Giungi, soffri, t’affini ed ami: / sbocci in gemme, ributti in rami. // Poi, dentro le fragili spoglie, / qualcosa d’oscuro si spezza. / E il grumo di pena si scioglie / in un mare di eterna dolcezza…» (2).
Sembrerebbe un verso di Ungaretti (e somiglianze con Il porto sepolto del 1916 e Allegria di naufragi del 1919 sono certamente indubitabili) così come il legame che entrambi ebbero con Ettore Serra starebbe a confermare. Ma in Jenco la lirica immediata e illuminante di Ungaretti si stempera nell’accordo e nel tintinnio della parola che è valore aggiunto al dato pregnante dell’immagine e non viceversa (come accade nel poeta dei calligrammi di ascendenza apollinairiana e della frase singola che si esaurisce in se stessa). Per Jenco, infatti, la poesia è un continuum che si prolunga nel corso della frase e si sviluppa, riarticolandosi, all’interno del componimento quale frutto di una scelta ascetica di riduzione al minimo del “grumo materiale” della scrittura.
Lo si vede bene, ad es., in questo testo, dal semplice titolo di Poesia del 1932 (appartiene – come il precedente – alla raccolta Cenere azzurra):
«Diafana creatura, / ti sento in me come un’anima senza peso, / che mi moduli la vita dura, / con mani d’aria, in gioco di luci sorpreso. // Volto non hai; ma dove più il buio si chiude / nei miei silenzi, tu cangi di perlato lunare / come le favolose fanciulle che affiorano nude, / tra risa d’acque, dai prati del mare… // E’ la tua nudezza vitrea, riflessa, / che traspare nei miei pensieri più schivi, / e trasfigura l’angoscia stessa / in un largo di canti sorgivi: // ché, quando in me incupa il dolore, / vento d’ombra in albero brullo, / la tua carezza mi cerca il cuore / per assopirmi come un fanciullo…» (p. 62).
Ritorna qui, con il consueto slancio lirico, il tema della mancanza del peso dei corpi, della latenza della terrestrità sposato, invece, ad una dimensione tutta mitologica dell’amore come forma del superamento della materialità della vita e come espressione del sogno di qualcosa che non c’è (e forse non c’è mai stato) ma che solo talvolta addiviene per effetto dell’abbraccio con la poesia.
C’è anche il tema della “cupezza d’amore” (che potrebbe far pensare al Pasolini degli anni più maturi) ma, ovviamente, senza la pesantezza del dolore come condizione esistenziale. Qui, infatti, la bellezza della nudità (solo vagheggiata e non descritta, peraltro) appaga e lenisce la pena dell’angoscia – ha quindi (almeno apparentemente) la stessa funzione della poesia nel liberare dalla pesantezza del mondo e proiettare l’anima in una dimensione molto fuori di essa.
La leggerezza, dunque, appare essere la cifra poetica dei versi di Jenco così come la fragilità dell’esistere che viene accoppiata ad essa come sostanza esistenziale della sua necessità.
Il “grumo”, il “peso”, il “pondo” sono ciò che rallentano l’anima dalla sua ascesa verso la sua dimensione più autentica ma questo non deve affatto far pensare all’abbandono della vena musiva che contraddistingue il rapporto lirico di Jenco con la natura della sempre amata (e spesso trasfigurata) Versilia. In Betelgeuse (poema contenuto in La vigna rossa che è del 1955), la natura della terra e quella che lampeggia e illumina il cielo si fondono in uno slancio panico che raggiungere le vette di una fusione estetico-estatica con la dimensione della configurazione tutta poetica di un mondo reso nuovo e rinnovato dalla potenza dei versi:
«Compenso a una pena d’alberi nudi, / il primo dolce soffio dal mare. / Sulla fronte delle paludi, / si fanno vive ombre di perla i frulli in ondoso migrare. // Le montagne si risvegliano su un bisbiglio / d’imminenti vite / e scintillano di gemme insolite al levare / dell’oradirosa. / Attesa di verdi alpeggi le consola dell’erbe contrite, / saldezza sognata, di soli, delle ghiacce le riposa. // Questo succedersi di luci e d’ombre, d’estati e / d’inverni, / è larga vicenda di cosmi: la legge dei mondi in / cammino; / e l’uomo, il labile specchio di terra, misura di eterni, / si modula, oscuro, a questo dei cieli fraterno destino. // Conforto all’ardente strazio dei solleoni / a me giunge il crepuscolo, aurora delle notti assorte: / cala in cuore una pace siderea, una calma bianca di costellazioni, / assaggio furtivo d’una quasi dolcezza di morte. // Morte, quiete d’astri. Del vivere stento che dura, / mi ripaghi tu, al colmo delle illuni notti sospesa, / o ferma vegliante promessa, mia patria futura, / fulgida Betelgesa…» (p. 92).
Nell’apoteosi dello splendore e della nitidezza degli astri che arricchiscono la volta notturna del cielo si consuma il desiderio di ricongiungimento totale alla Natura auspicato da Jenco.
La sua poesia si rivela qui capace di moti panici che salvano la materia attraverso la sua esaltazione mistica. In essa si respira quella dimensione “odorosa e trepida, musicale e calda come una creatura viva della mia terra, anzi è quella stessa terra da lui tanto amata – così prossima a quella dove son nato – e nella quale anch’io vissi felice” – di cui parla Ettore Serra (p. 109) nel suo Per Elpidio riportato da Fabio Flego in appendice all’antologia poetica.
La visione maestosa di Betelgeuse che si staglia nell’oscurità della notte e che salva l’esistenza umana dal gelo assurdo e incontentabile della Morte mediante la sua bellezza assoluta e irremovibile è il frutto più maturo della volontà di salvezza affidato alla poesia nel momento in cui essa si rivela lo strumento definitivo della sua possibilità e del suo desiderio di durare.
NOTE
(1) Elpidio Jenco, Betelgeuse. Antologia poetica, a cura di F. Flego, Viareggio (LU), Pezzini Editore, 2009, pp. 3-5.
(2) Elpidio Jenco, Betelgeuse. Antologia poetica cit. , p. 55.
***
[Quel che resta del verso n.8] [Quel che resta del verso n.10]
[Leggi tutti gli articoli di Giuseppe Panella pubblicati su Retroguardia 2.0]