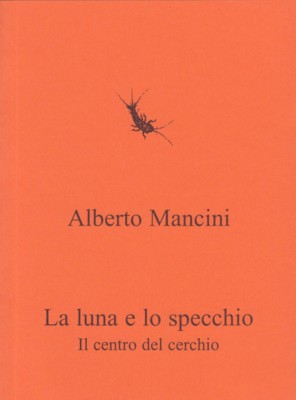 Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)
Il titolo di questa rassegna deriva direttamente da quello di un grande romanzo (Quel che resta del giorno) di uno scrittore giapponese che vive in Inghilterra, Kazuo Ishiguro. Come si legge in questo poderoso testo narrativo, quel che conta è potere e volere tornare ad apprezzare quel che resta di qualcosa che è ormai passato. Se il Novecento italiano, nonostante prove pregevoli e spesso straordinarie, è stato sostanzialmente il secolo della poesia, oggi di quella grande stagione inaugurata dall’ermetismo (e proseguita con il neorealismo e l’impegno sociale e poi con la riscoperta del quotidiano e ancora con la “parola innamorata” via e via nel corso degli anni, tra avanguardie le più varie e altrettanto variegate restaurazioni) non resta più molto. Ma ci sono indubbiamente ancora tanti poeti da leggere e di cui rendere conto (senza trascurare un buon numero di scrittori di poesia “dimenticati” che meritano di essere riportati alla memoria di chi potrebbe ancora trovare diletto e interesse nel leggerli). Rendere conto di qualcuno di essi potrà servire a capire che cosa resta della poesia oggi e che valore si può attribuire al suo tentativo di resistere e perseverare nel tempo (invece che scomparire)… (G.P.)
di Giuseppe Panella
Viaggio al centro della parola. Alberto Mancini, La luna e lo specchio. Il centro del cerchio, Roma, Lepisma, 2008
1. Allusioni e contatti: poesia come ricerca di sintonie armoniose
«Ancora parli, ancora parli; e guardi / le cose intorno. Piove. S’ avvicina / l’ombra grigiastra. Suona l’ora. È tardi»
(Marino Moretti, Poesie scritte col lapis)
Alberto Mancini è un poeta di atmosfere e di sensazioni, di sogni scaltriti dalla cultura e di ritmi segreti che scandiscono pian piano una situazione in bilico di attenta e quasi misteriosa sintonia con il passato che filtra, tuttavia, attraverso il presente. Il suo piano di scrittura si muove sempre in questa direzione. Nella sua breve (quanto densa) introduzione al primo libro di poesie di Alberto Mancini (Frammenti di voce, Perugia, Edizioni Guerra, 2006), Renzo Pavese esordisce così:
 «Con versi limati, sorvegliati e maneggiati fino a sentirli adatti ad accogliere il “respiro” dell’autore, e con qualche parola altamente letteraria e toscana, la poesia di Alberto Mancini, cadenzata spesso sulla varietà della strofa lunga dannunziana che si mantiene tra il quinario e il novenario, vibra moderna per “frammenti di voce”, esce “da fibre interne / nascoste nel […] cuore, / dal fondo della mente / ove lo spirito / a linfa si rapprende”, spazia tra natura e voli d’uccelli, su colli e tra alberi, a suono di sussurri “di cascate calme” e dello scorrere leggero di acque dai riflessi di “Arcadia”. Il ricordo e la memoria danno musica ai versi che dipingono la zona dell’Ambra e la sua valle, dove si scorgono un “baliginar di lasche a pelo d’acqua” e “trame di lucciole nei campi”, con colori dominati dalle “macchie / contorte delle more”, con i profumi dei “muschi” e delle “spighe” e con rintocchi di “campana”; nel presente, l’amata Arezzo e la campagna circostante» (Prefazione, p. 5).
«Con versi limati, sorvegliati e maneggiati fino a sentirli adatti ad accogliere il “respiro” dell’autore, e con qualche parola altamente letteraria e toscana, la poesia di Alberto Mancini, cadenzata spesso sulla varietà della strofa lunga dannunziana che si mantiene tra il quinario e il novenario, vibra moderna per “frammenti di voce”, esce “da fibre interne / nascoste nel […] cuore, / dal fondo della mente / ove lo spirito / a linfa si rapprende”, spazia tra natura e voli d’uccelli, su colli e tra alberi, a suono di sussurri “di cascate calme” e dello scorrere leggero di acque dai riflessi di “Arcadia”. Il ricordo e la memoria danno musica ai versi che dipingono la zona dell’Ambra e la sua valle, dove si scorgono un “baliginar di lasche a pelo d’acqua” e “trame di lucciole nei campi”, con colori dominati dalle “macchie / contorte delle more”, con i profumi dei “muschi” e delle “spighe” e con rintocchi di “campana”; nel presente, l’amata Arezzo e la campagna circostante» (Prefazione, p. 5).
Nel libro c’è in effetti tutto questo e in maniera talvolta liricamente assai ispirata, ma – a mio modesto avviso – c’è anche molto di più. Per verificarlo bisognerà leggere con attenzione la prima poesia della raccolta che si intitola programmaticamente (dal primo verso del testo) Qui non cercare suoni. In essa la ricerca poetica è determinata con fermezza dalla sua verifica fattuale:
«Qui non cercare suoni / piacevoli che volano / nel cielo senza un’ombra, / non li conosco, / altri i pensieri / ed i sensi che sereno / mi adagiano nel sonno, / voci che si serrano / di sera in spazi angusti, / avare a venir fuori, / che scoprono di me / ritagli d’anima. / Non parole estenuate / che rompono in astratti / giri, ma che salgono / da fibre interne / nascoste nel mio cuore, / dal fondo della mente / ove lo spirito / a linfa si rapprende, / finché i fiori profumano / e da laghi e monti per i venti volubili / tesi migrano gli uccelli»
(Alberto Mancini, Frammenti di voce cit., p. 11).
Ora qui è da notare subito (a parte la preponderanza delle r vibranti che ricordano certe zone molto musicali dei Sepolcri di Foscolo) che si è in presenza di un vero e proprio manifesto di poetica. La negazione iniziale (di chiara ascendenza montaliana) invoca però il rispetto per le affermazioni che seguono e che corrispondono ad una presa di posizione molto precisa di Mancini stesso sull’agire poetico (e sul modello lirico cui corrispondono le sue espressioni relative di scrittura).
Più che all’ et in Arcadia ego di seicentesca memoria, però, mi sembra proprio che in questi versi predomini un approccio di tipo volutamente immediato alla scrittura che salta, in questo modo, il livello della costruzione intellettualistica della proposta poetica (come accadeva, invece, nei modi artefatti dell’Arcadia). La poesia non appare come la costruzione artificiosa di “parole estenuate” che pure sarebbero facili da scrivere e da ritrovare nell’amplissimo corpus della tradizione lirica italiana ma come l’evocazione di voci che solo tardamente, “di sera” appunto, si palesano come forme di autentica esplorazione dell’interiorità. E’ in questa capacità evocativa che, da un lato, attraversa e illumina i limbi translucidi della soggettività (le”fibre interne nascoste nel mio cuore”) e dall’altro ha una sua fondazione razionale (“dal fondo della mente”) che scaturisce la poesia come forma di rappresentazione della bellezza del mondo e delle sue espressioni visibili e materiali (“finché i fiori profumano”).
Mancini ribadisce questa sua capacità di accostamento alla dimensione poetica attraverso tutta una serie di momenti di essere colti nella massa magmatica (e spesso apparentemente non visibile a primo colpo) della sua esperienza del mondo reale. Ne è sintomo una poesia raccolta tra quelle degli anni più maturi, A vegliare sul verso mi sorprendo (che riprende stilemi e accenni alla scrittura poetica dell’ultimo Sereni):
«A vegliare sul verso mi sorprendo, / a ben limare il legno grezzo / con lime differenti, a faccia dolce, / o dura e, se si oppone ancora, / a secondarlo ed anche ad inclinarlo, / ed io gradito alfin lo sento / reagire dolcemente tra le mani, a far suo allora il mio respiro»
(Alberto Mancini, Frammenti di voce cit., p. 112).
La scrittura è un’impresa materiale, faticosa e coerente negli scopi, fatta di avvicinamenti progressivi all’oggetto da far emergere, tutto polito e luccicante, dalla dimensione ancora grezza in cui riposava ancora incognito a se stesso e all’artefice che lo stava traendo dal suo informe apparecchio di parole ancora non composte in un disegno preciso e definito. Ma quello che affascina maggiormente in questo testo (che altrimenti potrebbe sembrare il frutto di un allegorizzare un po’ abusato, un po’ scontato) sono le lime “a faccia dolce” (o “a faccia dura”) non più (o soltanto) metafora dell’elaborazione del verso ma espressione concreta e direi materializzata dell’incidere, dello scavare, del togliere, dello scarnire e manipolare la materia dura dell’espressione che non vuole sempre cedere alla volontà e al desiderio di chi lo usa per ritrovare nella parola lirica il bandolo del proprio essere e vivere il mondo (accettandolo, rifiutandolo, piegandosi ad esso oppure – come scrivere Mancini – riuscendo ad “inclinarlo” perché si adatti alle richieste che ad esso vengono rivolte e inoltrate amorevolmente ma con decisione).
Ad un simile processo costruttivo del verso corrisponde la modalità stessa della scrittura del poeta di Arezzo: la materia evocata non viene fatta emergere bruscamente o improvvisamente ma la sua funzione espressiva può assurgere a poco a poco alla sua possibile vita solo mediante compensazioni o limitazioni – portata alla vita attraverso passaggi delicati ma sensibili alle fluttuazioni della realtà esterna e interiore. Quasi tutte le sue liriche nascono in questo modo, anche quelle redatte in anni ormai trascorsi. Si veda, ad esempio, una lirica intitolata Dentro mi ardo nell’ombra che appartiene a un mannello di testi datati 1963-1977:
«Dentro mi ardo nell’ombra / questa coscienza di pochezza, / quest’intimo letargo / di tutti i sensi / fra il rumore altrui, / l’assenza di te mi tormenta, / mi dimentico del mondo, / questo silenzio / che le fibre chiude. / Eppure, le ginestre / sono in fiore, sopra i prati / purissime corolle, / sui colli erte macchie di luce. / Il volto tuo vedo / in un palpitare legger / di più scure foglie al vento / e il cielo muore / piano nella sera» (Alberto Mancini, Frammenti di voce cit., p. 37).
Poesia questa di andamento più classico, più legato a stilemi di transizione di tipo crepuscolare, eppure connessa ai temi emergenti più significativi della scrittura di Mancini: ci sono già le “fibre” (che è evidentemente parola-chiave per la descrizione della sua soggettività) qui “chiuse” mentre nel testo analizzato precedentemente erano “interne” e “nascoste” ma che sono in ogni modo decisive per comprendere la natura schiva e riposta, umbratile (per riprendere il primo verso della poesia) della poetica crepuscolare che si può, a mio avviso, attribuire al poeta.
Probabilmente non è il solo Marino Moretti l’ascendente forte della sua scrittura lirica anche se è evidente come ne mantenga il tono volutamente dimesso (ma capace di articolare le situazioni più prepotentemente pre-poetiche in scatti e scansioni non banali e accensioni di senso). Mi pare, però, di cogliere con una certa sicurezza proprio il timbro dell’operazione che contraddistinse la stagione crepuscolare di allora, a inizio secolo scorso, con la sua dimensione “rivoluzionaria” di riduzione dei tempi (e delle volute amplificate) del verso rispetto al suo sviluppo lungo e “ardito” nella tradizione carducciana (poi rifluita e ricomposta in quella “immaginifica” di D’Annunzio). E’ noto, infatti, che proprio quello che sembrò riduttivo e sminuente ai critici di allora e lo consegnò alla storicizzazione successiva sotto la categoria della rinuncia all’epicità e del ripiegamento nel grigiore del quotidiano, permette oggi di valutare appieno lo scarto, la differenza di prospettiva tra quelle due proposte di modello artistico.in un’ottica di rivalutazione e recupero della scrittura di Moretti e dei suoi seguaci.
Qui, allora, Mancini produce mediante l’utilizzazione di uno stile medio e spesso (solo) apparentemente riconducibile alla semplicità assoluta di certe situazioni di base un rovesciamento della tradizione novecentesca che vuole nella “parola assoluta” o nella stringenza delle singolarità liriche il trionfo della Poesia. Ne risulta l’evidenza programmatica (e la scelta tutt’altro che ingenua) nel testo poetico-elegiaco che egli ha scritto per onorare la dipartita di Mario Luzi (uno degli altri suoi poeti di riferimento) e in cui, parlando dello scomparso, illumina di luce trasversa anche il suo ideale di espressività lirica non contaminata da volontà (e voluttà) pioneristico-avanguardistiche:
«VISTO MAI NON HO IL COLORE (In memoria di Mario Luzi). Visto mai non ho il colore / delle tue iridi, da cogliere l’aspetto d’uccello / in volo dopo la caduta. / Da tempo sondavi / della spera comune / oltre il crinale i fili azzurri / delle cose, la natura / nobile degli uomini, / scialba e senza un’anima / soltanto in apparenza. / Dentro di me, sento / si è perduto al pian terreno / della nostra vita / l’ultimo maestro / sacro di parole. / Il diapason, la tua poesia, che sempre risuonavi, / le vie nascoste / aveva trovato / che fanno accogliere / del miele amaro / l’imperfetto sapore. / Raro tesoro ormai, / amica ti ha raccolto / una morte discreta; / a rive calme ti conduce / ora nell’eterno cielo / e, certo, anch’esso fori / come la terra un seme / che rispunta e cresce / e subito s’infiora» (Alberto Mancini, Frammenti di voce cit., p. 125).
Qui la differenza la fanno “i fili azzurri delle cose”, la prospettiva di ricerca e di definizione della sacralità della vita che ha contraddistinto la produzione dell’ultimo Luzi, piuttosto che “la natura nobile degli uomini” (tematica che accomuna Mancini al poeta fiorentino). Non solo – rispetto alla poetica assoluta e religiosamente rivolta verso il cielo di Luzi (“l’ultimo maestro sacro di parole”), quella del poeta di Arezzo è, invece, assai più relativa e certo più rassegnata a non cogliere neppure “l’imperfetto sapore” del “miele amaro” che la poesia può concedere a chi la corteggia con l’abito dorato della trascendenza. Mancini si pone (come si è detto) programmaticamente dall’altra parte dei “fili azzurri delle cose” e preferisce non aver conosciuto “il colore delle iridi” della poesia solenne e sacrale che intinge le pagine finali di Luzi.
Alla sua scrittura si confà, invece (come si vede bene in questo primo libro antologicamente articolato per anni in sezioni spesso anche molto diverse tra loro per tono e per taglio) una prospettiva diversa di poesia – certo più dimessa ma anche più concentrata sulle verità della vita terrena. Una poesia, cioè, fatta di situazioni concrete e di sogni fatti ad occhi aperti, di vicende minime ma reali e di aperture di senso che vogliono giustificarle in un ambito più vaso e più soffuso di tiepida e tenera malinconia.
2. Scavo e ricerca come prospettiva lirica dell’Io
«Ma che è che vaga nell’aria? / Ed ecco vien di laggiù / l’eco di un canto, di più / canti, cento arie in un’aria .// Non parlare, anima mia; / prima che venga una stella / giriamo la manovella / d’un organo di Barberia. // Fai che questo tuo poeta / che vive così distante / dal mondo chieda a un passante / una piccola moneta. // Taci dunque, anima mia; / mentre che scende la sera / andiamo dove ci conduce / questo suono, andiamo via»
(Marino Moretti, Poesie scritte col lapis)
Questa volontà di canto sarà maggiormente accentuata e avvalorata in questa nuova raccolta di testi più recenti che qui si presenta e che ha un titolo assai più ambizioso rispetto alla prima. Alla “luna” e allo “specchio”, da sempre immagini luccicanti che richiamano alla possibilità di riflettersi nella scrittura come in una forma della natura e da sempre metafore dell’operare stesso del poeta, si collega la sua impossibilità (trovare e poi situarsi al centro del cerchio e configurarlo come la dimensione assoluta e stabile della ricerca poetica). Se la luna e lo specchio sono di fronte al poeta, il misterioso centro del cerchio è quello che pur gli sfugge sempre e che sempre, tuttavia, viene inseguito, ricercato, voluto con forza, desiderato e poi sempre perduto.
Nella poesia che ne apre il ventaglio di proposte liriche, Cantare con parole (che è poi anche il titolo della prima delle tre sezioni che compongono il volume), l’autore è esplicito nel confermare la sua richiesta di maggiore musicalità alle parole:
«Cantare con parole, / immergersi nel vero, / che nascosto rimane anche a lui stesso, / il vero che sta al fondo, / e non si vede o tocca, ma traspare / a chi suole guardare nel segreto, più chiuso e interno, e vuol scoprire dove. // E parlano d’amore, / e non sembrando penetrano dentro / nei recessi più cavi del tuo cuore, / svelando come udibile il dolore, / il sapore di vivere, dell’esistere nostro, / gli smarrimenti, i dubbi, anche le colpe. // Non avere che sillabe sonore, / inadeguate, rigide, ritrose, / che a fatica si piegano a ridire / il bianco e oscuro grumo della vita, / e tuttavia provare e riprovare» (Alberto Mancini, La luna e lo specchio. Il centro del cerchio, p. 35).
Anche qui le “fibre eterne” sono al centro della prospettiva di canto del poeta che ne coglie la permanenza “al fondo” della sua ricerca di esistenziale soggettività.
Le parole non risultano soltanto la pura espressione di superficie dei sentimenti di chi vuole affidargli il proprio messaggio di canto ma hanno una loro ragion d’essere, sono scavo e ricerca nella profondità assoluta dell’essere, sono proposta d’amore rivolta al mondo. La verità delle parole, in questo modo, coincide con la loro capacità di ritrovare nelle profondità esplorate il senso ultimo, il sapore definito, il colore preciso delle esperienze di vita fino ad allora rimaste vaghe e indefinite, anche se confitte nel cerchio più largo dell’esistenza.
Attraverso quelle parole l’amore ritrovato per la vita si manifesta (anche se in maniera imperfetta e non completamente plausibile) in tutte le sue possibili gamme espressive e quell’incertezza che le contraddistingue (le “sillabe inadeguate, rigide, ritrose”) più che una condanna sembra essere il premio per lo sforzo fatto.
Fin dall’inizio, allora, questo nuovo libro di Alberto Mancini si presenta con i caratteri di una ricerca che vuole andare al fondo del reale e delle cose che lo rappresentano sondandone le possibilità esclusive e riservate ai modi della poesia. A differenza dell’opera precedente, dunque, è concesso maggior spazio all’introspezione come strumento di analisi e la riflessione sul livello alto (e profondo in termini evocativi) dell’attività poetica sembra interessare maggiormente il suo autore. Ne è prova anche l’ottavo testo della raccolta (Si svelano alla mente) dove i problemi previsti nell’accettazione delle difficoltà relative all’uso delle parole di fanno elogio e approfondimento del mistero ad esse relativo:
«Si svelano alla mente le parole / accanto a percezioni, / dal privato silenzio, / dalle pieghe nascoste, sconosciute, / di luoghi giù sepolti, ed è un incontro nato da magia. // E un mistero le fonde / soltanto in un momento, / note adatte a cantare in melodia, / ma presto ad affondare sono pronte, / come accade nel mare / a sparsi gusci vuoti / quando intorno li cinge / un po’ dappresso un’onda, / e poi trabocca e cola / e tutti li ricolma, / e loro, pieni, rapidi s’immergono / ed ondeggiando scendono nell’ombra. // Anche va colto il croco / soltanto in un momento, / quando il colore al sole più s’infiora, / ma senza troppo stringere, / ché, a volte, tra le dita / reclina e si scolora»
(Alberto Mancini, La luna e lo specchio. Il centro del cerchio, pp. 48-49).
Il ritorno poetico del croco, il saffron così caro alla tradizione anglosassone del Modernismo di Virginia Woolf è qui inquietante metafora di una scrittura che si rivela (come quel fiore) timido ma sempre orgoglioso di essere se stesso e di fiorire nei luoghi superbi della fecondità creativa. Come scrisse la Woolf in un saggio, “Il croco e il committente”, sicuramente non ignoto a Mancini:
«Lo scrittore che si è commosso alla vista del primo croco ai Kensington Gardens, prima d metterlo nero su bianco dovrà dunque scegliere, tra una folla di concorrenti, il committente a lui più gradito. Non serve dire “lasciali perdere tutti, pensa solo al tuo croco”, perché scrivere è un mezzo per comunicare; e il croco è un croco imperfetto finché non sia divenuto patrimonio comune. Il primo o l’ultimo degli uomini potrà scrivere solo per se stesso, ma sarà un’eccezione e per di più un’eccezione non invidiabile, e gli sciocchi leggano pure la sua opera, sempre che ne siano capaci» (Virginia Woolf, Il lettore comune, a cura di Daniela Guglielmino, trad. it. di Daniela Sanna, Genova, Il Melangolo, 1995, p. 236).
In questi suoi versi programmatici (e comunque di riflessione sul destino della scrittura poetica) e melanconici quanto basta rispetto all’argomento (come sempre accade in questa raccolta, comunque), Mancini si concede, allora, sia al rimpianto per la caducità dell’arte (ars longa, vita brevis!) sia alla sua emergenza che si trasforma (come sempre accade nelle sue pagine) in metafora di eventi della vita (il naufragio e i suoi relitti, il fiorire del croco e il suo progressivo sfiorire). Scrivere significa inseguire la vita, dunque, e cercare di inserire il frutto della sua produzione in una visione più generale che gli permetta di inquadrare in essa le possibilità dell’esistenza. Le parole affondano nella melodia che gli ha permesso di comporsi in immagini poetiche dopo essere emerse dagli spazi privati e segreti della coscienza e, quindi, dopo essersi manifestate come espressioni della poesia che si portano dentro, ritornano là da dove sono venute ricolme di senso. Allo stesso modo, i relitti marini ripongono nel gorgo marino la loro sorte ulteriore e il croco fiorisce per spegnersi subito dopo aver rivelato il suo massimo fulgore.
In un testo sistemato assai più avanti nella raccolta (si tratta del n. 75 intitolato Sentire), Mancini ritorna su questa sua prospettiva e la amplia molto verificandola sulla base di una metafora che implica tutta la gamma dell’esperienza sensoriale:
«Sentire al tatto cose, / le scabre superfici o levigate, / rumori udire, armoniche / volubili assonanze, / il sapore gustare della mandorla, / quando il suo mallo ancora / è tutto fresco e verde, / il rosso di un tramonto, / nell’aria un buon profumo, / luminosi i capelli di una donna, // E quel che nei profondi / nascosti sensi ascolto / non so dire, m’illude la certezza / di una vera, reale / sicura rispondenza. / E, sorpreso, mi avvedo basterebbe / un’insignificante differenza / a riformare il mondo, / a variare per me il più udito suono. // Basterebbe che avessi, / anche solo di poco, / diversamente programmati i sensi / dal naturale modo nel qual sono» (Alberto Mancini, La luna e lo specchio. Il centro del cerchio, pp. 166-167).
Ritorna qui il motivo esistenziale della conoscenza e della sua difficile conquista, motivo cosmico di disappunto e di disincanto interiore ma anche di fresca letizia e capacità di godimento della dimensione esterna e non ancora devastata delle cose. L’elogio della levigatezza del mondo coincide con l’accettazione dell’impossibilità a conoscerlo. L’”insignificante differenza” che segna il tratto di confine tra conoscere e non afferrare in profondità la ragione vera, reale dell’esistere della realtà è, per Mancini, però, la ragione (altrettanto profonda e incontrovertibile) dello scrivere poesia. La poesia (forse – il dubitativo è d’obbligo!) è quello che riesce, per la sua forza interiore e per la sua capacità di ri-organizzare il magma della vita irrelata e magnifica cui si contrappone, a colmare il vuoto e a riempirlo di un senso (ulteriore e aggiunto) che lo spiega e lo svela.
Il poeta è, quindi, colui che accetta il dislivello di essere e apparire come non superabile evento della vita e lo trasforma in parola che dice questa differenza illuminandola sotto il fuoco (fatuo?) della sua volontà di canto e di sogno lirici ed esistenziali.
Per i motivi che si è cercato di esporre prima, dunque, e per la volontà poetica di agire in sinergia con il corpo e i sensi utilizzati quali tastiera di un (immaginario) pianoforte che sarebbe il mondo, le figure topiche della caratterizzazione lirica dell’esistenza (la natura, l’Io, la soggettività dispiegata) si raddensano, quasi si raggrumano in apparenze riflettenti che il mondo rimandano come immagine totalizzante. E’ il caso della Luna (qui leopardiana certo ed anche mitologizzata ma anche riportata giù verso il mondo degli uomini grazie ai viaggi di scoperta culminati nell’estate del 1969):
«La luna si riaffaccia, / rosata si dilata sopra il monte, / sembra incerta a staccarsi / dalla terra, a librarsi, / tenuta da una forza, / da oscure ed ondulate masse d’ombra. // Ora s’innalza ripida, / inizia il suo cammino, / e per le arcuate vie ruota nel tempo, / lei esperta di cicli e di stagioni, / fonte di luce quando / più soli si è nel buio, / madre che parla quando / il sole si fa muto. // In sé i miei sensi aggruma, / ed il pensiero perdo / nel buio, nel mistero. // Mi rimane l’enigma del suo volto, / il candido sembiante / appare sempre uguale, / da esatta mano pare predisposta, / da una parola eterna, / un giorno forse detta / con un calcolo astrale di distanze / a suscitare voglia di sapienza, / o l’uomo, forse, vuole in lei rifletta» (Alberto Mancini, La luna e lo specchio. Il centro del cerchio, pp. 170-171).
La Luna non riflette ma ritrova la propria verità nel cono d’ombra in cui vive e si innalza. Anch’essa (lo si vedrà accadere allo stesso modo nella sequenza dedicata allo specchio) sembra voler “riflettere un momentino, prima di riflettere le immagini” – come dichiara Jean Cocteau proprio riguardo alla natura degli specchi nel suo Testamento d’Orfeo.
La Luna è il simbolo del mistero, dell’altra faccia della vita. E’ per questo, probabilmente, proprio per la sua natura misteriosa e fantasmatica, che in essa si annida la poesia la quale si palesa proprio quando, invece, sembrerebbe essere venuto il momento meno adatto o più difficile per la sua realizzazione. La sua natura femminile e materna le permette di esporre la propria saggezza arcaica e primordiale nel momento in cui quella più solare e aperta del giorno è decisamente tramontata.
Il suo sapere, tuttavia, resta legato alla ripetizione eterna e sempre uguale della vita ed al suo enigma pur sempre insondabile è legata – descriverla non equivale a conoscerla e conoscerla dal punto di vista scientifico e astrofisico comporta l’accettazione dei suoi ritmi, non la verifica della sua verità.
Quest’ultima, infatti, può essere ottenuta solo a partire dalla riflessione che gli uomini riescono a compiere su di essa e ad essa va rimandata come compimento di un sogno secolare.
Anche lo Specchio, simbolo inesausto e inesauribile dell’Io e della sua scissione non più sanabile dopo le grandi crisi della soggettività del Novecento filosofico e letterario rivela la stessa prospettiva di crisi del senso che si fa sovrabbondanza del significato:
«Chi osserva dal suo chiuso l’altrui vita / e solo da lontano / i bei cavalli guarda / mentre assetati bevono, / o corrono veloci la pianura, / o quando dall’amor nasce l’amore; chi soltanto ha uno specchio all’esistenza, / uno specchio distorto, / e scorrere la osserva dall’esterno, / può forse anche pensare / di rivedere ancora / l’immagine di un’aquila nel nido, / il piccolo col becco / puro ancora di sangue / che freme e sta in attesa. // O ritenere possa riprodursi / quel tramonto del sole di una sera, / che tinge rosa l’acqua, / le rotonde colline, / e d’opale splendore t’innamora. // E non ne vive assorto la bellezza, / gli sfugge come l’acqua tra le dita. // Chi la vita conosce, nei segreti, / ruba attento sull’acqua / a una vaga libellula il colore, / quando si libra e in voli / svagati e lesti subito rivola, / e sa che tutto appare / soltanto in un aspetto, / e in quello un’altra volta non ritorna» (Alberto Mancini, La luna e lo specchio. Il centro del cerchio, pp. 172-173).
Dall’impossibilità di cogliere definitivamente e globalmente il senso dell’esistere riflettendolo come in uno specchio non distorto attraverso il suo aspetto cangiante, multiforme e ricco di bellezza nasce il disincanto della poesia di Mancini. Un disincanto non pessimisticamente coniugato, però, nella dimensione del materialismo coerente ma sconfortato di una certa parte della poesia di Leopardi (tanto per portare una facile esemplificazione sui temi proposti) quanto, invece, addolcito dalla mestizia del canto e dal sapore mai troppo agglutinato di cenere della nostalgia del passato e del tempo non più richiamato al suo destino di sogno.
Come nel testo poetico di Marino Moretti citato in esergo, Mancini vuole spendere la sua “piccola moneta” senza eccessivi rimpianti e se questi ultimi pure vi saranno sarà la poesia con il suo implicito e sognante splendore (che duri almeno un giorno! – come nelle epifanie romantiche del miglior Wordsworth) a ridare lucentezza e vigore all’erba del mattino trascorso. Il canto e l’evocazione del verso saranno sicuro strumento di salvazione dall’oblio.
***
[Quel che resta del verso n.2] [Quel che resta del verso n.4]
[Leggi tutti gli articoli di Giuseppe Panella pubblicati su Retroguardia 2.0]